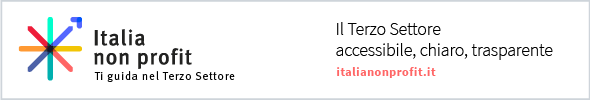Progettazione culturale tra rinnovati strumenti di governance e sostenibilità
La diffusa considerazione che il patrimonio culturale italiano non sia pienamente valorizzato ha alla base motivazioni di natura giuridica e amministrativa? Sono necessari nuovi strumenti per ripensare le governance del patrimonio culturale, con una collaborazione piena tra pubblico e privato? Qual è l’impatto degli ultimi provvedimenti introdotti dal Mibact?
Ne parliamo con Francesco Florian, notaio in Milano, docente dell'Università Cattolica in Legislazione dei beni culturali che, insieme al notaio Enrico Bellezza, è stato l'ideatore della figura della fondazioni di partecipazione, nate alla fine degli anni '90 guardando ai trust di matrice anglosassone e alle fondazioni olandesi, modello che ha conosciuto una grande adozione, non sempre risolutiva nell’efficacia.
E' comunemente considerato un mantra quello che vuole il nostro patrimonio culturale non sempre debitamente valorizzato. Come descriverebbe la situazione attuale?
Il settore dei beni culturali è stato uno dei primi a muoversi verso forme innovative di gestione, di valorizzazione ed erogazione di servizi, trovando anche soluzioni tecnicamente avanzate rispetto ad altri settori. Oggi mi pare in arretramento rispetto alle dinamiche di altri settori, perché a fronte di una strutturazione giuridica, fiscale e contrattuale favorevole non leggo la vivacità progettuale presente nei settori dei servizi assistenziali e della persona che, tradizionalmente, è “meno titubante” nell’azione. Nella maggior parte dei progetti in corso che vedono protagonisti il mondo associativo, il bene culturale è sullo sfondo, coinvolto sì, ma marginalmente.
Quali, secondo la sua esperienza, le motivazioni di natura giuridica e amministrativa alla base di questo stallo?
Norme tutorie che da un lato rispondono a una reale esigenza, un corretto e trasparente impiego di denaro pubblico, ma che trascinano con sé una rigidità concepita per altri settori quali le costruzioni di nuove infrastrutture. Si tratta di beni completamente diversi: primo perché sono già realizzati, secondo perché rispondono ad altre logiche di uso e impiego.
Il settore dei beni culturali, inoltre, sconta certamente il fatto di non fornire un servizio considerato essenziale come quello socio assistenziale. Comunque oggi vediamo come il dialogo tra i due settori possa portare al recupero del bene culturale in ottica di fruizione sociale.
Sotto l'aspetto giuridico le architetture che stiamo elaborando sono proprio queste: fondazioni che hanno come riferimento la comunità territoriale "stanziale", in cui il bene culturale vincolato ospita progettualità e servizi assistenziali, soprattutto quando si esce dalle grandi città.
Un caso recente che ho avuto modo di affrontare, ad esempio, riguarda una Villa in stile liberty al confine tra Italia e Svizzera originariamente progettata per accogliere persone affette da patologie mentali. Oggi il progetto di recupero la vede destinata a luogo ricreativo in cui le attività sanitarie sposano quelle culturali e artistiche in un contesto ambientale che valorizza l'immenso Parco quale luogo di rigenerazione con attività rivolte ad un vasto pubblico. Lo ritengo un segnale molto positivo.
A suo avviso, al di là delle grandi città, quali territori possono divenire laboratori dove sperimentare nuovi modelli di governance?
L’Italia ha la caratteristica di avere un patrimonio culturale diffuso capillarmente in ogni zona del nostro Paese. Si deve perciò partire da un territorio definito, delimitato e caratterizzato da alcune specificità: una provincia, una valle. Quando si ha come riferimento territoriale una vallata, ad esempio, ci può essere un'attenzione al patrimonio artistico costituito da siti di interesse locali uniti a beni culturali di rilevanza nazionale. L'iniziativa della gestione dei luoghi d’arte viene presa tendenzialmente dall'assessorato alla cultura o promossa da un'associazione culturale per poi estendersi ad altri soggetti. Ritengo che, anche in questi casi lo strumento organizzativo ideale rimanga sempre quello della fondazione, in cui il consiglio di amministrazione rappresenti la rete dei portatori d’interesse del territorio, non per mero meccanismo di rappresentanza, ma per competenze. Questo è stato ed è un nodo critico nell’esplosione del modello, unitamente al patrimonio, prevalentemente insufficiente per assicurare autonomia all’ente.
Sotto l’aspetto del patrimonio, oltre al fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferiti dai Fondatori, in primis l'ente pubblico, sarebbe opportuno dedicare singoli fondi a specifiche linee di attività anche con funzioni di garanzia.
Ci sono fondazioni di "nuova generazione" o nuovi impianti formali e organizzativi?
Il modello delle fondazioni di partecipazione può assumere una duplice veste: da un lato può mantenere la forma dell'unitarietà con un fondo di dotazione e di gestione, con un unico bilancio; nel contempo può coesistere una plurima articolazione, tante quante le linee di intervento della fondazione. Ad una strutturazione fisiologica con semplici dipartimenti, oggi si affiancano spesso altrettanti fondi patrimoniali ad hoc, ad esempio legati ai beni culturali, su cui è possibile sollecitare una raccolta fondi dedicata.
Il fondo può assumere anche i tratti di un fondo di garanzia per finanziamenti bancari. Chiunque decida successivamente di concorrere, partecipando alle attività ad esso correlate, non è obbligato ad interessarsi a tutta la rete alla quale il fondo continua ad essere connesso.
In questa formula non ci sono alterazioni della governance tipica, né duplicazioni di organi: un solo consiglio, uno solo presidente, uno solo direttore.
Questo modello funziona nelle valli o in città medio piccole, in cui il patrimonio culturale è diffuso, ma i beni sono spesso sentiti come risorse identitarie e si percepisce una maggiore "solidarietà" che stimola un effetto benefico sulla gestione. Nelle grandi città c’è più individualismo.
Il modello giuridico ha avuto evoluzioni nell’applicazione?
L’impianto dello statuto si è semplificato con l'aumentare dell'attenzione sulle questioni più generali legate alla governance. E' andato riducendosi lo spazio dedicato alle specificazioni statutarie inerenti le diverse tipologie dei partecipanti, che oggi si preferisce definire più generalmente partner.
Il collegio dei partecipanti, originariamente organo con funzione consultiva, oggi viene strutturato meglio: è diventato un organo rappresentativo di tutti i beneficiari dell'attività della fondazione e di tutti coloro che la sostengono.
Si è assistito ad un progressivo aumento della trasparenza dell'impiego dei fondi a disposizione: sia dei singoli progetti, che dell'attività generale della fondazione, per consentire la comprensione dell’utilizzo delle risorse con un'illustrazione puntuale del bilancio aperta a tutti.
Essendo stato riscontrato un basso tasso di litigiosità interna, sono sparite le clausole arbitrali originariamente previste per dirimere eventuali controversie nascenti tra i vari soggetti che via via si aggregano alla fondazione.
Sotto il profilo gestionale le strutture sono più solide organizzativamente, con una distinzione più netta tra le funzioni degli organi e quelle degli uffici ed è sempre più presente la figura del direttore generale; in ambito culturale (come accade in quello scientifico), si parla sempre meno di direttore artistico, ma sempre di più di direzione artistica, un aiuto a smussare i personalismi. Da questo punto di vista lo statuto può aiutare.
Quali i suggerimenti nella redazione degli statuti?
Fondamentale lo sforzo in fase di costituzione, specie in termini istruttori per capire qual è il contesto in cui nasce ed opererà la fondazione ed una preventiva opera di astrazione che garantisca la massima copertura a tutte quelle attività, magari originariamente non preventivate, a cui la fondazione vorrà eventualmente dedicarsi.
Da un lato tutto ciò si traduce in un'articolazione maggiore del meccanismo dei fondi separati cui si faceva prima riferimento, che possano fungere da finanziamento ad iniziative imprenditoriali, dall'altro si assiste ad una più specifica e netta definizione delle linee di intervento della fondazione: le finalità, l'attività istituzionale e l'attività strumentale.
Prendiamo ad esempio un palazzo storico: anche se il fine è il suo restauro, tuttavia l'attività generale non potrà ridursi ad esso. Come ben identificato dal Codice dei beni culturali si dovrà poter incidere sulla sua valorizzazione attraverso un'attività istituzionale che si traduca ad esempio in un percorso museale ed espositivo, ed una meramente strumentale (es. bookshop, caffetteria, merchandising...).
Seguendo questa direzione non è affatto infrequente affiancare a fondazioni che perseguono finalità culturali strutture operative più commerciali - soprattutto in forma di S.r.L. – per una più profittevole apertura al mercato. Si assiste così ad una conversione dell'attività commerciale in non-profit, perché elevata al livello superiore della promozione dell'attività culturale.
E’ chiaro che questo è percorso complicato quando alla fondazione partecipa un ente pubblico, ma non è impossibile perché assolta la procedura di trasparenza non si è vincolati da grossi divieti normativi.
Da questo punto di vista il settore dei beni culturali è stato il primo a fare applicazione di nuove forme gestionali complesse, per trovare canali di finanziamento, anche di natura commerciale.
A proposito di finanziamento e fiscalità, viste le recenti introduzioni del c.d. decreto Franceschini, come valuta l'art-bonus e quale potrebbe essere, a suo avviso, il suo impatto sul patrimonio culturale?
Mi pare in generale una scelta apprezzabile. Come è noto l'art. 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 ha introdotto un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% effettuate nel 2016 in favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di sostegno, restauro e potenziamento dei luoghi della cultura.
Alla prima lettura di un interprete del diritto, tuttavia, le scelte di dettaglio possono apparire un po' “particolari”. In primis in merito all'oggetto destinatario delle donazioni. Si tratta di beni pubblici o appartenenti a soggetti pubblici o a soggetti di qualsiasi natura affidatari di beni pubblici, anche se è certamente una ragione di opportunità ad aver mosso il legislatore, laddove oggi è notoriamente il proprietario pubblico ad avere maggiori difficoltà nel tutelare il proprio patrimonio rispetto a quello privato che gode già di alcune agevolazioni.
I dubbi maggiori si riscontrano quando parliamo di deducibilità della donazione.
La nuova disposizione legislativa – come precisato nella relazione illustrativa al decreto-legge – mira, infatti, ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando l’attuale dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che riconosce una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.
Rimangono, tuttavia, limiti massimi di spettanza del credito nonché modalità di fruizione differenziata a seconda del soggetto donante. Così, alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi. Per questi ultimi soggetti, tradizionalmente nella disponibilità di operare sforzi erogativi maggiori (sia che si tratti di persona fisica che riceve redditi da attività commerciale, sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale), il credito di imposta risulta fortemente limitato.
Cosa comporta in termini di donazioni?
Che per le donazioni superiori al 5 per mille non vi sia un reale vantaggio. Anzi, verrebbe da dire che per esse rimarrebbe più conveniente il regime previgente che però risulta espressamente disapplicato dal comma 1 che prevede la sospensione ai fini IRES, dell'art. 100, comma 2, lettere f) e g) del TUIR.
Questo può voler dire soltanto che si è scelto di muoversi scientemente verso un'unica direzione: incentivare le donazioni piccole, diffuse, continuative ed omogenee.
Si tratta in termini assoluti di una scelta intelligente, ma certamente non risolutiva. Forse si sarebbe potuto avere un po' più di coraggio e propendere per una deducibilità totale.
Confrontando il mancato gettito dell'imposta con quello complessivo derivante dalla attività culturali connesse, potremmo paradossalmente arrivare a constatare che in realtà per lo Stato non si è percepita alcuna perdita, anzi, nel frattempo è riuscito a recuperare anche parte del suo patrimonio culturale immobiliare.
Con il trend recente, soprattutto a livello di patrimonio diffuso, di una forte riappropriazione da parte delle comunità dei loro territori, l’invenzione di iniziative interessanti e funzionali può tradursi in un vero e proprio ritorno strutturale e non in una perdita di gettito.
Certo bisognerà valutare il fenomeno al termine dei tre periodi di imposta.
Qualsiasi sia l'entità dei contributi raccolti sarà necessario operare una semplificazione delle procedure legate al loro impiego.
E' chiaro che il donor vorrà avere contezza del risultato del proprio sforzo e sarà quindi interesse dell'ente pubblico di riferimento rendere tangibile il progetto nel più breve tempo possibile. Altrimenti si rischia di disincentivare le future donazioni.
Ecco perché, come dicevo in apertura, diventa fondamentale epurare le procedure da norme non espressamente previste per i beni culturali. Del resto è evidente come la farraginosità che dimora nel settore pubblico stia soffocando una rigenerazione creativa degli spazi non solo culturali.
In conclusione da questa attenta lettura sembra emergere un ordinamento a due velocità. Quello che afferisce alla sfera privatistica, che costantemente si arricchisce di modelli di gestione perlopiù rinnovati al fine di rispondere ai mutati contesti di fruizione, e quello pubblico, ancora difficilmente in grado di creare le condizioni per un reale sviluppo del settore culturale anche in termini di produttività.
Se le nuove linee di indirizzo dettate dai provvedimenti targati Franceschini sembrano far intravedere qualche spiraglio, è il contesto di complessità e di scarsa flessibilità e rapidità dell'apparato burocratico-amministrativo a rappresentare il maggior ostacolo al processo di reale valorizzazione del settore dei beni culturali.
E allora è forse proprio alla ricchezza dell'immenso patrimonio diffuso del territorio italiano che bisogna guardare, in particolar modo a quei beni o a quelle reti in cui modelli di gestione valorizzano la partecipazione dei cittadini quali primi custodi, fruitori e perché no anche finanziatori dei loro interventi di recupero.
© Riproduzione riservata