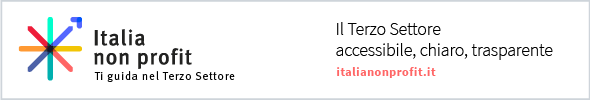Patrimonio sotto sussidio
Il dibattito sulla trasformazione di Brera in Fondazione di diritto privato oppone storici dell'arte a storici dell'arte, responsabili della tutela a «decisori» e economisti. Con l'attribuzione alla Fondazione della duplice competenza su beni immobili e collezioni il governo è apparso consolidare la fuorviante distinzione tra «tutela» e «gestione», svilendo le funzioni pubbliche di custodia, pure previste dalla Costituzione. Esistono garanzie che gli obiettivi scientifici e didattici risultino vincolanti anche in futuro? Inoltre: è ammissibile che il problema della riqualificazione delle competenze pubbliche sia ancora una volta tralasciato?
Un convegno organizzato dall'Associazione Bianchi Bandinelli ha da poco richiamato l'attenzione sull'emergenza in cui versano le professioni della tutela. Scavi archeologici e campagne di catalogazione sono affidate a giovani precari mentre crescono collaborazioni esterne con società prive di personale qualificato. Si moltiplicano i manifesti per «sviluppo e cultura» ma lo Stato taglia le cattedre di storia dell'arte negli istituti tecnici e perfino in quelli turistici. A che pro, deve avere pensato il legislatore, insegnare chi fossero Veronese, Palladio o Valadier a futuri geometri, progettisti di servizi culturali per la Rete o guide?
«Impresa innanzitutto», stabiliscono gli esperti del Sole 24Ore nel ripresentare il «Manifesto della cultura» in edicola. «La cultura ha bisogno di uno spirito imprenditoriale nuovo capace di superare vecchi steccati e vecchie ideologie». Concordiamo. Ma la domanda è: innovazione, efficienza o «spirito imprenditoriale» coincidono necessariamente con «privato»? Potremmo supporre che non sia sempre così. Esiste un modello politico-istituzionale specificamente italiano, esemplificato dall'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e dall'Opificio delle Pietre Dure, che ha riscosso nei decenni il più ampio riconoscimento internazionale: un'agenzia tecnica centrale a finanziamento pubblico capace di porre in connessione ricerca, conservazione e didattica. Questo stesso modello oggi è in crisi perché sottofinanziato: per incuria o ostilità politico-ideologica, in altre parole, non per impasse interna.
Il Principe e il Leviatano
È utile, prima di prendere posizione, provarsi a chiarire dizionari, poste in gioco e presupposti ideologici di una querelle assai intricata, caratterizzata da ampie reticenze da parte istituzionale. I sostenitori del principio di sussidiarietà si rivolgono a società civile e «corpi intermedi», cioè associazioni di cittadini, fondazioni, onlus e via dicendo. Questi, si afferma, devono potersi fare carico in primis dei compiti di conservazione del patrimonio. Il monopolio pubblico della tutela, stabilito dall'articolo 9 dellla Costituzione, è divenuto una forma degenerativa di welfare che produce cattiva gestione e «rendita politica»: nientemeno che la mutazione in chiave socialdemocratica del Leviatano di Hobbes. Da qui la necessità di concedere fiducia all'iniziativa «relazionale» e al «desiderio socializzante» di «benefattori» privati.
La mostra Ad Usum Fabricae, allestita al meeting CL di Rimini 2012 sulla base delle ricerche d'archivio di Marina Saltamacchia, ricostruiva la vicenda delle donazioni pro-Duomo di Milano in chiave di iniziativa sussidiaria (l'intera manifestazione era pressoché dedicato al tema «sussidiarietà»). I documenti mostrano che Gian Galeazzo Visconti partecipò per circa il 16% del costo totale: non di più. All'impresa contribuirono invece cittadini di ogni classe sociale e professione, donando in proporzione alle proprie possibilità. La storia preunitaria di regioni e città, questa la tesi degli organizzatori, prova quanto l'iniziativa comunitaria abbia contribuito a edificare cattedrali.
Afflati neorisorgimentali
All'intreccio tra cultura della tutela e politica del «bene comune», rivendicato da Settis, Montanari e altri, si oppone, da parte «neoguelfa», che il «bene comune» non è esterno alla persona, al contrario: esso presuppone il senso di appartenenza e non coincide con alcunché di istituzionale. Né con il patrimonio né con l'ambiente o la Carta costituzionale e neppure con la nozione di «Nazione» e «Patria». «Vivo e vitale nella cultura», ha di recente affermato il ministro per i Beni culturali «è quanto è cultura di popolo». Difficile contestare l'afflato neorisorgimentale.
Ma cos'è «popolo» per un teorico delle élite? Allo stesso meeting CL si è potuto ascoltare Ornaghi intrattenere il pubblico sul tema della «bellezza della politica» in un incontro che ci si attendeva dovesse essere dedicato alle politiche del patrimonio. L'intervento ha avuto caratteri teorici e certo non intendeva premiare nessuna tra le parti politiche in competizione. La scelta di ricollocare la politica in ambito (anche) estetico lasciava tuttavia sconcertati. Cosa ha a che fare la «bellezza» con l'evocazione del Principe o la sua auctoritas? Arte e tutela non sembrano chiamate a consacrare gerarchie sociali tradizionali.
Le fondazioni bancarie, proclamate indipendenti dalla politica (ma non lo sono affatto!) e stimate più trasparenti di quanto non risultino essere dall'ex presidente della Compagnia delle Opere, Giorgio Vittadini, tra i tanti, sarebbero designate a partecipare ai «semimercati» assieme ai «benefattori» individuali. È indubbio che attorno al principio di sussidiarietà fervano oggi qualificate riflessioni politiche, economiche e giuridiche. Abbiamo presenti le proposte di Alberto Quadrio Curzio sulla differenza tra «beni economici» e «beni sociali», utili a distinguere la posizione cattolico-liberale da quella tout court economicista. Ha tuttavia senso riporre così grandi aspettative nei «privati illuminati», quasi spettasse a questi finanziare tutela e ricerca?
Pasquale Gagliardi, segretario generale della Fondazione Cini, obietta: «In Italia manca il mecenatismo classico perché è assente un adeguato sistema per la defiscalizzazione dell'investimento culturale. Negli Stati Uniti c'è la corsa per avere il proprio nome sulla targhetta sotto un quadro. Da noi c'è troppo familismo anche in questo. Si lasciano i beni agli eredi, raramente alla società. L'Italia è un paese di clientele, di salotti buoni, di imprese piccole e poco attente al sociale». Consiglio assai prudente giunge dall'interno della classe imprenditoriale italiana. «Da noi non ci sono Bill Gates che fanno una fondazione benefica e ci mettono dentro 20 miliardi di dollari», sibila Cesare Romiti in un'intervista-autobiografia apparsa da qualche mese (Storia segreta del capitalismo italiano, Longanesi 2012). «Non ci sono tanti soldi, e a pensarci bene non ci sono nemmeno gli imprenditori alla Bill Gates».
Non pretendiamo di affrontare un problema tanto complesso con una boutade, sia pure dell'ex amministratore delegato del gruppo Fiat. Colpisce tuttavia che, a fronte delle perplessità espresse da più parti sull'effettiva disponibilità di capitali privati, i sostenitori del principio di sussidiarietà non contemplino per lo più neppure per un attimo la possibilità di riqualificare le competenze pubbliche che si propongono in larga parte di liquidare. Quanto sacrifichiamo, nel discutere di patrimonio, a un eccesso di litigiosità pregiudiziale? La nomina di un filosofo del diritto alla presidenza del Consiglio per beni culturali, non di un archeologo o di uno storico dell'arte, conferma i timori che l'avversione ideologica, non la valutazione delle competenze, orienti le scelte dell'attuale ministro. I dilemmi della tutela sono da affrontare su piani concretamente storici e sociali: non esistono modelli validi a priori, in altre parole, bensì compatibilità specifiche, suggerite dal contesto nazionale.
L'eredità sotto le scarpe
Le aziende italiane che adottano strategie di comunicazione orientate all'arte e al patrimonio perseguono obiettivi di riconoscibilità internazionale: obiettivi legittimi, sia chiaro, ma disgiunti dal proposito civile e partecipativo che può orientare l'attività di un'istituzione pubblica. Il contesto globale ipercompetitivo rende fiorente il marketing delle identità culturali. Diego Della Valle sostiene i costi del restauro del Colosseo per difendere l'immagine complessiva del «brand» Italia: lo stato di abbandono dei monumenti o i recenti crolli in aree archeologiche non giovano alla buona reputazione del made in italy. Luca di Montezemolo adotta lo slogan «Italian Heritage» per lanciare le collezioni di scarpe Poltrona Frau.
Si intesta così una tradizione culturale che le pedanti retoriche del mestiere connotano in modo assai povero e sommario. Giova alla collettività la riduzione del Grande Stile cinque-secentesco a artigianato di calzature? Possono davvero risultare vincenti, e quanto a lungo, aziende che all'innovazione tecnologica preferiscono la patina del Tempo? Miuccia Prada condivide i timori di Della Valle. «Percepisco ancora nel pensiero di una certa sinistra e di certi intellettuali - afferma la stilista - una grande diffidenza verso la ricchezza... Molti intellettuali italiani hanno ragione a essere rigorosi, rifiutano ogni commistione commerciale per proteggere il nostro patrimonio, forse non amano i grandi numeri e temono il grande pubblico. Ma se si rifiuta di cavalcare questo tipo di modernità,... allora bisogna inventare un sistema di attrazione più intelligente e sofisticato». Prada non intende essere arrogante e non denigra gli avversari. Le si deve anzi riconoscere di essersi prestata a rendere pubbliche le sue opinioni e di avere avviato un dialogo: non accade spesso.
La polemica contro una determinata (e ben riconoscibile) comunità di storici dell'arte è tuttavia marcata. Colpisce che un'imprenditrice innovativa non colga il punto di vista altrui. Appare del tutto conseguente che persone che dedicano tempo e risorse alla ricerca credano alla sua importanza civile e si battano per politiche culturali non incentrate sull'esposizione-evento, invocata invece da Prada. Ci chiediamo: perché non promuovere studi, pubblicazioni o progetti educativi invece che grandi mostre affidate a «curatori» di logora reputazione?
L'intima connessione tra ricerca, museo e territorio che ha sin qui caratterizzato la cultura italiana della tutela gioverebbe non poco anche al contemporaneo. Dove sta scritto che l'arte, al pari della moda, debba necessariamente divulgare finzioni di grandiosità e indifferenza? La storia del modernismo italiano, sino ai primi anni Sessanta, è attraversata dalla convinzione che i compiti civili dell'arte, per citare Cesare Brandi, «impegn(i)no la responsabilità morale dell'artista non meno che quella di qualsiasi altro uomo».
Condizioni di appartenenza
Suona severo, senza dubbio, ma non c'è motivo di ignorare che la cultura italiana, anche quella più celebre sul piano internazionale, non ha sempre dovuto disprezzare la semplicità. In questione non è un'astratta «diffidenza verso la ricchezza», ma la contestazione di pratiche culturali votate alla sua irriflessiva celebrazione. Costumi di responsabilità e cura sono forse meno inventivi? Riteniamo che una parte almeno del "mondo della ricchezza" di cui parla l'imprenditrice apprezzerebbe mutamenti di narrazione e potremmo perfino riuscire a immaginare un mondo dove la moda attinge dall'arte nel rispetto della diversità di quest'ultima, anziché pretendere di imporle quei ruoli ancillari che spettano piuttosto alla pubblicità.
Stabilito che il vincolo affettivo tra collettività e memorie (o «patrimonio») è presupposto prezioso quanto instabile di ogni efficace politica di tutela, vale la pena interrogarsi sulle condizioni storiche e sociali attraverso cui può concretamente prodursi qualcosa come il senso di comunità.A differenza di una qualsiasi eredità familiare ben protetta, oggi la «appartenenza» può e deve essere promossa di generazione in generazione e per così dire costruita da politiche educative lungimiranti.
L'autoriproduzione delle élite tradizionali o delle cerchie detentrici del «buon gusto» in contesti cittadini premoderni non costituisce modello per le società democratiche, caratterizzate almeno in linea di principio da mobilità sociale. Servono istituzioni dedicate e processi di reclutamento fluidi e trasparenti. «La formazione dei quadri - come scrive Settis -è cosa di vitale importanza per il futuro del nostro patrimonio culturale». Appunto. «I costi delle politiche economiche fallite», aggiunge Amartya Sen, "vanno ben oltre le statistiche, pure importanti, della disoccupazione, del reddito reale e della povertà. L'idea stessa di unione, di un senso di appartenenza (nazionale e sovranazionale), è messa in pericolo da quanto accade in campo economico».
La riduzione o cancellazione degli insegnamenti storico-artistici negli istituti di formazione secondaria o la mancata assegnazione di risorse utili a chiamare in ruolo soprintendenti giovani e qualificati sono distruttive sotto il profilo della trasmissione (e dell'accoglimento) di un'eredità disciplinare condivisa. Persino a un autorevole commentatore di economia come Fabrizio Galimberti risulta indiscutibile che «l'Italia sia un paese che avrebbe bisogno (più di altri) di molta (e buona) spesa pubblica... per l'immenso patrimonio artistico da conservare». Quali concrete implicazioni educative può avere, in un contesto di crescente definanziamento della ricerca pubblica, l'applicazione del pricipio di sussidiarietà?
Un'autonomia insidiata
È prevedibile che l'ingresso di fondazioni bancarie nei consigli di amministrazione dei musei si accompagni alla maggiore politicizzazione degli incarichi culturali. Questo comporta insidie per l'autonomia degli studi. Ci sta bene? La contesa sulla tutela ha implicazioni profonde sul piano sociale, e i modelli di Fondazione di cui disponiamo non sono tali da autorizzare illusioni. Solo talune università private con rilevanti protezioni politiche e ingenti coperture economiche potrebbero divenire soci fondatori e offrire migliori opportunità professionali ai loro studenti e ricercatori, risultando fatalmente più attrattive. Quale migliore habitat di formazione o ricerca, per uno storico dell'arte o un'archeologo, se non il museo? Dovremmo provvedere a garantire modelli educativi che prevedano la più stretta collaborazione tra enti pubblici di tutela e università accessibili al grande numero.
Dovremmo incoraggiare i «capaci e meritevoli». Ci accingiamo invece a favorire i pochi e abbienti.
Da il manifesto del 30 ottobre 2012
Michele Dantini è saggista e critico. E' professore di storia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avocadro" e ne dirige il Master MAED - Educational management per l'arte contemporanea. E' visiting professor presso università nazionali e internazionali.
Articoli correlati:
Privatizzazioni, un dibattito aperto
Proseguono i nostri ascolti sul tema della cooperazione tra pubblico e privato, paradigma che non decolla nella nostra nazione
Grande Brera
Strenua difesa alla privatizzazione della gestione dei musei pubblici. Ma quali le alternative?