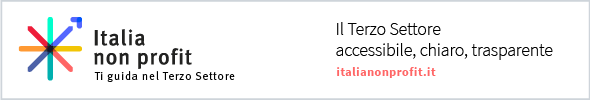Patrimonio e integrazione interculturale: le buone pratiche esistono ma non godono della giusta visibilità, soprattutto tra i nostri politici
Simona Bodo è ricercatrice e consulente in problematiche di diversità culturale e inclusione sociale nei musei. Su questi temi cura studi, seminari, pubblicazioni, percorsi formativi e di progettazione per istituzioni pubbliche e private, tra cui Gallerie degli Uffizi, Pinacoteca di Brera, Fondazione Ismu – Iniziative e Studi sulla Multietnicità e Fondazione Cariplo. La pubblicazione più recente da lei curata è «Un patrimonio di storie. La narrazione nei musei, una risorsa per la cittadinanza culturale» (con S. Mascheroni e M. G. Panigada, Mimesis 2016). Le abbiamo chiesto di identificare i progetti più innovativi ed efficaci in tema di l’interculturalità e di dare qualche consiglio al prossimo governo.
Rubrica di ricerca in collaborazione con il Museo Marino Marini
Il ripensamento del ruolo del patrimonio come strumento di sviluppo economico ma soprattutto sociale, l’adozione di nuove modalità di sviluppo dei « pubblici della cultura» o, ancora, la promozione dell’arte come strumento di integrazione sono al centro delle tematiche trattate da questo giornale. Il programma da lei coordinato « Patrimonio e Intercultura» è quindi per noi di grande interesse: come nasce e quali sono gli obiettivi?
Il programma «Patrimonio e Intercultura» nasce nel 2005 da un’importante intuizione di Fondazione Ismu - Iniziative e Studi sulla Multietnicità: quella di aprire un nuovo filone di ricerca e intervento dedicato al patrimonio culturale, accanto a quelli già consolidati e più tradizionali come l’economia e il lavoro, la salute, il welfare, l’educazione.
È stata un po’ una scommessa, perché in quegli anni le esperienze di educazione al patrimonio in chiave interculturale nei musei italiani si contavano ancora sulla punta delle dita. E questo non ci dovrebbe sorprendere: non solo perché, storicamente, molti musei (in Italia e in Europa) sono stati creati con il preciso intento di affermare l’identità di una nazione, di una città, di un gruppo, e di celebrarne i valori dominanti, ma anche perché la nozione stessa di patrimonio, in virtù della sua stretta associazione con il concetto di eredità, sembra riferirsi a qualcosa che è acquisito una volta per tutte per diritto di nascita.
Eppure – in un periodo come quello attuale, segnato da una vera e propria ossessione nei confronti dell’identità come fattore di esclusione, di discrimine tra «chi appartiene» e «chi non appartiene» – la sfida sta proprio qui: ripensare il patrimonio non più come «sistema chiuso», ma come un corpo vivo con cui chiunque può intrecciare un dialogo.
Queste, in estrema sintesi, sono le riflessioni che hanno portato Fondazione Ismu a promuovere il programma Patrimonio e Intercultura. I principali obiettivi che Silvia Mascheroni ed io (insieme a Mara Clementi per la progettazione europea) ci siamo poste in questi anni di intenso lavoro sono stati indagare e sperimentare sul campo il ruolo dei musei come spazi pubblici strategici per la promozione di nuove appartenenze; attivare una piattaforma per facilitare sinergie, confronto e scambio di pratiche tra operatori non solo culturali e sociali, ma anche creativi; contribuire alla costituzione sul territorio italiano di una comunità di riferimento sempre più ampia, interdisciplinare e aggiornata riguardo a tutte le tematiche connesse alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio in una società plurale.
Tutto questo attraverso percorsi formativi, pubblicazioni, giornate di studio, la co-progettazione di percorsi interculturali in partenariato con istituzioni museali, e naturalmente l’omonimo sito Patrimonio e Intercultura, che rappresenta una risorsa unica nel suo genere in Italia e in Europa. Un dato significativo: nella sezione «Esperienze» sono ad oggi documentati ben 82 progetti, diversi dei quali all’avanguardia sotto il profilo delle finalità e dell’impianto metodologico. Il che ci indica che nei tredici anni dall’avvio del programma di Fondazione Ismu i musei italiani hanno maturato un patrimonio significativo di consapevolezze e competenze, che purtroppo non sempre gode della giusta visibilità e soprattutto di quel quadro politico e istituzionale che dovrebbe garantirne la continuità. Si tratta di acquisizioni tutt’altro che scontate e definitive, ma che al contrario vanno costantemente salvaguardate e alimentate, per contrastare quella che nel 2006 lo studioso Tony Bennett ha chiamato la «fragile reversibilità del multiculturalismo». Parole quanto mai attuali!
Dal suo osservatorio di ricercatrice che da anni lavora su questi temi e in base agli stessi risultati di questo programma, quali sono, secondo lei, i tre progetti più innovativi ed efficaci che hanno fatto del patrimonio strumento di integrazione di comunità immigrate, in Italia e/o all’estero?
Restando in Italia, indicherei innanzitutto il progetto «Mediatori Museali» della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, un caso esemplare – e direi quasi unico nel panorama nazionale – di continuità, progressione e cambiamento istituzionale. All’inizio degli anni 2000, la GAMeC ha incominciato ad affrontare la questione della partecipazione culturale dei migranti, a partire dalla consapevolezza che i «nuovi cittadini» non erano per nulla rappresentati nel pubblico del museo. Nel 2007 ha lanciato un corso di formazione che ha portato alla creazione di un gruppo permanente di oltre trenta mediatori di origine immigrata; questa prima apertura del museo all’importanza di accogliere nuove voci, come del resto il progetto Mediatori Museali nel suo complesso, è stata fin da subito concepita come una iniziativa culturale piuttosto che “sociale”: non si trattava solo di promuovere l’«accessibilità», ma di un chiaro impegno da parte della GAMeC a esplorare nuove strategie di interpretazione e mediazione, tali da facilitare nuove connessioni tra le persone e le collezioni e superare il linguaggio autoreferenziale del museo, spesso elitario ed esclusivamente fondato sull’expertise disciplinare. Il confronto con i Mediatori Museali per la progettazione partecipata di iniziative culturali è divenuto negli anni elemento costante della politica culturale della GAMeC, grazie a un lavoro lungo e complesso e a un continuo investimento nella formazione dei mediatori, spesso condivisa con gli educatori museali e di volta in volta mirata all’acquisizione di specifiche competenze progettuali, operative e relazionali.
Un’altra esperienza esemplare – anche se purtroppo conclusa – è quella della Pinacoteca di Brera, che nel 2012 ha affidato a un gruppo di otto mediatori (provenienti da diverse parti del mondo, ma anche dall’Italia) la creazione di percorsi narrati intorno alle collezioni. «Brera: un’altra storia» è un esempio affascinante di come anche un grande museo statale di arte antica possa mettersi in gioco in quella «rilettura» dialogica, partecipata e inclusiva del patrimonio di cui parlavo prima. La rilevanza sociale di questo progetto risiede nella promozione di diversi livelli di accessibilità: lo sviluppo di una nuova familiarità tra Museo e «nuovi cittadini», la partecipazione del non-pubblico italiano (in particolare i giovani), la promozione nei visitatori abituali di nuovi punti di vista sulle collezioni e, più in generale, la costruzione di politiche per l’accesso e la partecipazione rivolte a un pubblico interculturale, e non «segmentato» in base all’appartenenza etnica.
La narrazione come chiave di accesso al patrimonio culturale (cui è dedicato il volume Un patrimonio di storie. La narrazione nei musei, una risorsa per la cittadinanza culturale a cura di S. Bodo, S. Mascheroni e M.G. Panigada) è il terzo esempio che citerei, anche se non riferito a un progetto solo, ma a una pluralità di esperienze che negli ultimi dieci anni sono state realizzate in musei molto diversi tra loro: non solo la Pinacoteca di Brera e la GAMeC di Bergamo, ma anche il MAXXI, il Museo Pigorini e il Museo di Zoologia di Roma, il Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, il Museo Popoli e Culture del Pime. Accanto alla scelta di utilizzare la narrazione come linguaggio comprensibile a tutti, capace di innescare nuove consapevolezze sul rapporto che ogni individuo può intessere con oggetti apparentemente distanti come quelli conservati in un museo, il filo rosso che collega questi progetti è l’intento di lavorare alla creazione di comunità interpretative eterogenee, allargate e inclusive, coinvolgendo italiani e «nuovi cittadini» su un piano di parità, e mettendo in moto nuovi saperi, consapevolezze e relazioni, fondamentali nella costruzione di una società plurale.
Un altro tema che a noi sta molto a cuore è quello della valutazione degli impatti, sicuramente fondamentale per portare «evidenze» utili ad informare il dibattito pubblico, ma spesso soggetto a limiti concettuali e metodologici. Una delle azioni previste dal programma Patrimonio e Intercultura è proprio quello di «proporre modalità e strumenti innovativi per la progettazione e la valutazione di initiative in partenariato istituzionale museo-scuola e altre agenzie formative». Quali modalità di valutazione sono state testate in questi anni e quali suggerirebbe di applicare altrove?
Il nostro principale impegno di questi anni è stato quello di diffondere una cultura della valutazione che ancora oggi stenta a mettere radici nelle istituzioni museali, e che diventa tanto più urgente in un contesto – quello dell’interculturalità – dove i malintesi e certe ingenuità ancora abbondano.
Per questo, ancora prima di parlare di impatti sociali, crediamo sia importante promuovere una riflessione attenta su cosa significhi progettare in chiave interculturale, su quali siano i presupposti fondamentali in assenza dei quali questa modalità di progettare diventa problematica se non impraticabile in un museo, e quali siano le sue ricadute sulla «cultura istituzionale». Abbiamo pubblicato linee guida e manuali per gli operatori, promosso percorsi di formazione e ricerca-azione, messo a punto strumenti (penso, solo per fare un esempio, al questionario di autovalutazione per aiutare gli attori coinvolti a mappare bisogni, vincoli e risorse del proprio contesto, ricomporre la storia progettuale e interculturale dell’istituzione di appartenenza, declinare l’ipotesi progettuale in relazione alla specifica realtà istituzionale e territoriale) a partire dalla convinzione che l’azione valutativa non debba essere «atto finale», ancora troppo spesso ridotto alla semplice rilevazione e comunicazione di dati e risultati, ma puntuale riflessione sulle coordinate culturali, metodologiche e operative assunte per un progetto nel suo complesso, e filo conduttore di un confronto ininterrotto tra tutti gli operatori coinvolti.
La posta in gioco è alta, perché non si tratta solo di «rendicontare», quanto di garantire la sostenibilità, sistematicità e continuità di progetti che, per quanto all’avanguardia, faticano ancora troppo spesso ad essere acquisiti a livello istituzionale.
Il risultato delle elezioni in Italia e, più in generale, la deriva populista che la politica sta assumendo a livello mondiale delinea un quadro preoccupante, in cui sforzi ancora maggiori saranno necessari per mettere al centro delle nostre politiche la cultura come strumento di crescita, innovazione e inclusione. Quali sono i messaggi che darebbe ai nuovi eletti, nella (forse vana) attesa della formazione del nuovo governo?
Negli ultimi anni, in Italia e in Europa, abbiamo assistito a una successione ininterrotta di raccomandazioni indirizzate ai policy maker, e in alcuni casi sollecitate dai policy maker stessi: sto pensando ad esempio ai recenti rapporti predisposti da gruppi di esperti degli stati membri dell’Unione Europea nell’ambito del Metodo di coordinamento aperto (nel 2014, quello dedicato al ruolo delle istituzioni culturali pubbliche nella promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale; nel 2017, al ruolo della cultura e delle arti nella promozione del dialogo interculturale nel contesto della crisi migratoria). L’impressione, un po’ disarmante, è che molte di queste raccomandazioni finiscano in un cassetto. E in ogni caso, qualsiasi sollecitazione da parte mia rischierebbe di suonare ripetitiva rispetto all’ottimo lavoro già svolto da tanti esperti e operatori del settore.
Forse, invece di inviare messaggi ai politici, sarebbe più utile (e provocatorio) invitarli a stare dentro a un museo, toccare con mano che cosa significhi coinvolgere cittadini italiani e di origine immigrata in una rilettura condivisa del patrimonio. Proprio di recente mi ha colpita una iniziativa promossa dall’associazione dei musei olandesi, e poi mutuata da NEMO - Network of European Museum Organisations, che organizza programmi di tirocinio nei musei per i politici. Se si facesse una cosa del genere in Italia, mi chiedo quali effetti potrebbe produrre sui nuovi eletti trascorrere un po’ di tempo in un museo come la GAMeC di Bergamo!
© Riproduzione riservata