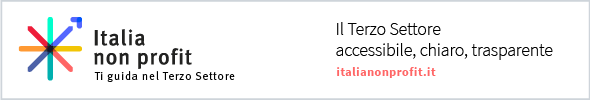Le Fondazioni ai tempi della crisi
Uno dei principali problemi del non profit italiano è sempre stata la mancanza di organizzazioni con un elevato livello di patrimonializzazione che potessero – proprio in virtù di quel patrimonio, senza dover remunerare alcun tipo di azionista – avere la possibilità di guardare lontano e sostenere grandi operazioni di innovazione sociale. Operazioni queste spesso precluse al nostro settore non profit, piccolo, frammentato, molto dipendente dall’amministrazione pubblica e pertanto spesso vincolato alla logica della sopravvivenza e ai desideri dei committenti.
La nascita delle fondazioni di origine bancaria ha aperto una grandissima opportunità, nonostante sia stata per molti aspetti casuale, priva com’era di un chiaro disegno filantropico e legata alla necessità di affrontare problemi del mondo bancario.
Proprio l’origine bancaria, se da una parte ha messo a disposizione patrimoni di cui nessuna altra organizzazione non profit disponeva, dall’altra ha segnato – almeno inizialmente – lo stile di azione delle fondazioni. Da allora è stata fatta molta strada, ma il cammino per trasformare fino in fondo queste istituzioni in autentiche fondazioni filantropiche è ancora in corso, stretto tra le pressioni di relegarle a ruoli subalterni rispetto alle amministrazioni pubbliche (specie locali) o di considerarle ancora holding finanziarie (in campo bancario o in altri settori). Ne parliamo con Gianpaolo Barbetta, professore di economia dei sistemi di welfare all’Università Cattolica di Milano.
Come si muovono oggi le Fondazioni di origine bancaria?
Credo che non tutte abbiano deciso fino in fondo in che direzione andare, in un mondo che offre diverse possibilità di orientamento, che danno l’idea di un universo diversificato, composito e pluralistico. Questo «pluralismo degli approcci», per una parte rilevante dell’infrastruttura sociale del nostro Paese, rappresenta una condizione per tutelare e riprodurre la democrazia e come tale va favorito e sostenuto. Allo stesso modo però, va favorita la riflessione sul loro ruolo sociale: vogliono essere holding finanziarie al servizio delle banca che governano? Oppure soggetti collaterali rispetto alla pubblica amministrazione del territorio in cui operano (e al servizio di quest’ultima)? Oppure soggetti pienamente autonomi che parlano e interagiscono con altri, ma hanno caratteristiche costitutive e strutturali che le rendono indipendenti e diverse dall’amministrazione pubblica, dal resto del settore non profit, dal settore privato? Credo che proprio dalla capacità di sfruttare sapientemente queste caratteristiche strutturali, dipenda la possibilità per le fondazioni di origine bancaria di fare del «bene» per il Paese, di giocare un ruolo decisivo.
Qual è il nodo? Perché la situazione non si sblocca?
Ne vedo più di uno. Il primo sul versante delle amministrazioni pubbliche, che sono in una condizione di grave difficoltà economica e finanziaria e dalle quali arriva continuamente la richiesta di risorse per affrontare i problemi emergenti. Una richiesta molto forte in un Paese che non ha ancora compreso appieno l’impellente e ineludibile necessità di rivedere il livello e la composizione della spesa, tagliando sprechi e inefficienze. E’ difficile per gli amministratori delle fondazioni sottrarsi alla continua e insistente richiesta, anche perché in molte circostanze gli organi stessi delle fondazioni sono, almeno in parte, espressi dalle amministrazioni pubbliche locali. Si fa fatica a dire no a chi ti ha nominato. E poi immaginare di poter disporre di un tesoretto non assoggettato ai vincoli del patto di stabilità e alle sue perversioni, da utilizzare con una certa libertà e flessibilità per perseguire le priorità è una tentazione molto forte per le amministrazioni.
In questo campo c’è un grande lavoro culturale da fare, da entrambi i versanti, per dimostrare che questo non è il modo migliore per usare le risorse delle fondazioni, che – tranne rarissime eccezioni – non sarebbero sufficienti a risolvere i problemi della casa, della disabilità, dell’attrattività del territorio, dell’inquinamento..., nemmeno se decidessero di concentrarsi su uno solo di questi problemi. Meglio allora usarle per fare ciò che possono fare meglio rispetto alle amministrazioni pubbliche e al resto del settore non profit: prendersi il rischio dell’innovazione nel modo di affrontare i problemi, nel tentativo di trovare soluzioni più efficaci e meno costose, sperimentarle e valutarne gli esiti. Le fondazioni sono luoghi aperti a molte sollecitazioni e si trova spesso al centro di reti di idee, di modelli interpretativi della realtà differenti rispetto ai tradizionali. Questa condizione, unita alla disponibilità di risorse, le pone nella condizione di poter sperimentare modi nuovi per affrontare problemi tradizionali. Il vantaggio comparato rispetto all’amministrazione pubblica e al resto del Terzo Settore, consiste proprio nella possibilità di assumere rischi, metter insieme soggetti diversi, valutare in modo oggettivo e neutrale i risultati delle innovazioni, senza la necessità di dover dimostrare che le cose vanno bene. Ciò permette loro di guardare lontano, contribuendo a scoprire modi nuovi di affrontare i problemi collettivi.
Quale relazione con la sfera pubblica?
Dovrebbe cambiare la logica della produzione delle politiche pubbliche, che in questo Paese si fanno spesso sulla base di a priori ideologici. Oggi abbiamo un modello che si ripete: il decisore politico stabilisce cosa bisogna fare e poi chiede i finanziamenti. L’esito è che, non solo si sprecano i soldi delle amministrazioni pubbliche, ma anche quelli delle fondazioni. Se sono solo una cassaforte, che senso ha mantenerle come soggetti autonomi? Meglio dare i patrimoni direttamente alle amministrazioni locali risparmiando costi di transazione. Credo che questa non sia la soluzione e che il Paese abbia bisogno di altro. E’ indispensabile aumentare il tasso di pragmatismo e provare ad affrontare laicamente alcune questioni: ad esempio, verificare se – per favorire l’autonomia degli enti culturali oppure la diffusione della cultura – sia meglio finanziare musei e teatri a piè di lista, oppure erogare loro un contributo per ogni biglietto staccato o per ogni euro di donazione raccolta. Oppure vedere se, invece di realizzare restauri di emergenza su ogni monumento quando cade a pezzi, possiamo muoverci nella logica della manutenzione programmata e se questo, in un arco temporale medio lungo, consente di risparmiare risorse. Ancora, chiederci se, anziché sostenere ogni singola micro-iniziativa culturale su un territorio, non convenga organizzarle sotto forma distrettuale, così da integrarle con la produzione di servizi accessori alle industrie culturali, e via così.
Siano le fondazioni il luogo in cui si selezionano le idee innovative potenzialmente più efficaci, dove si finanzia la sperimentazione per migliorare le modalità con cui si risponde ai bisogni cittadini, dove si introduce una valutazione seria, indipendente, distaccata sull’efficacia delle azioni. Se la sperimentazione raggiunge il risultato previsto, allora l’amministrazione pubblica trasforma questo modello applicato su scala locale, in una politica generale. Si crea così quella che potremmo battezzare «una filiera delle policy»,in cui le fondazioni, con ruoli distinti, lavorano unitamente alle Amministrazioni Pubbliche, ai soggetti del Terzo Settore, alle Università e ai produttori di conoscenza per definire congiuntamente i problemi da affrontare e le soluzioni – potenzialmente più valide – da sperimentare per affrontarli. Le fondazioni sostengono e realizzano la sperimentazione i cui esiti saranno utilizzati a un tavolo comune per costruire un nuovo sistema dei servizi.
L’amministrazione pubblica fatica ad adottare una logica sperimentale, perché la sua legittimazione è basata sul consenso. Deve lasciare ad altri questo ruolo. La diffusione dell’innovazione non può che essere fatta dall’amministrazione pubblica, perché richiede risorse che sono un multiplo rispetto a quelle di cui le fondazioni dispongono.
La spinta sulla «progettualità propria» delle fondazioni, soprattutto nella cultura, è molto discussa.
Sotto questo capitolo s’incontrano azioni con segno differente. Progettualità propria significa che la fondazione, invece di finanziare qualcun altro, opera direttamente, trasformandosi da «erogativa» a «operativa». Sono scettico su questa tendenza. Credo sia un errore e che rischi di creare «monumenti» ai Presidenti di turno. Che senso ha che le fondazioni di origine bancaria, che hanno un patrimonio significativo rispetto al resto del settore non profit, diventino in tutto e per tutto simili ad altre fondazioni operative? Perché dovrebbero mettersi a erogare per conto proprio servizi, aprire il proprio museo, la propria scuola, la propria casa di riposo? Avremo un buon museo in più, ma forse questo non è ciò di cui abbiamo principalmente bisogno. L’ideale sarebbe avere un’organizzazione in grado di valorizzare le ricchezze sparse di cui disponiamo e di renderle, congiuntamente, capaci di fare concorrenza al Louvre. Per raggiungere questo risultato non serve aprire un nuovo museo.
Sono cresciute le erogazioni a bando, un buon strumento per orientare le istituzioni culturali alla progettualità, costringerle al pensiero strategico.
Sicuramente è così, ma il bando serve principalmente per finanziare la diffusione dell’innovazione che è stata già sperimentata e validata. Per arrivare a un bando ben costruito le fondazioni devono sviluppare una strategia, individuare un percorso, scegliere obiettivi specifici. Tutto ciò è un bene, ma il bando ha un limite fondamentale, intrinseco nello strumento: non permette di «verificare le ipotesi», cioè di valutare in modo scientifico gli effetti degli interventi che si gestiscono. Se la fondazione vuole capire se un nuovo modo di inserire i disabili sul lavoro è efficace, è difficile che riesca con un bando attraverso cui finanzia una pluralità di soggetti che gestiscono modelli d’intervento tendenzialmente non omogenei e standardizzati. In questo caso la valutazione seria, quella che usa tecniche «controfattuali», non si può fare, o è molto più complicata.
Questa è la circostanza in cui vedo positivamente un progetto proprio della fondazione, il che non significa che farà tutto da sé, ma che finanzierà alcuni soggetti per effettuare la sperimentazione, sulla base di un protocollo rigoroso per valutarne scientificamente gli effetti. Questo risultato può essere ottenuto solo se la fondazione governa il processo e quindi se ingaggia soggetti che sono disponibili a collaborare. Il significato del termine «progetto proprio» è molto condivisibile se si lavora con soggetti diversi per definire le ipotesi da verificare e poi le si sperimenta sul campo. Tutto ciò richiede uno strumento diverso dal bando.
Molti capitali – pubblici e privati – sono «ingessati» nelle partecipazioni in enti nati dalla trasformazione di realtà pubbliche.
Il meccanismo pareva virtuoso, ma il sistema non ha favorito un chiaro miglioramento della gestione di questi enti. Tutte le circostanze in cui le risorse s’ingessano, non fanno che favorire lo spreco. I nuovi enti lo sono spesso solo di nome, perché i loro patrimoni non generano alcun rendimento e anzi, in qualche circostanza, rappresentano un costo. Credo che le fondazioni di origine bancaria debbano evitare di bloccare risorse su esperienze operative, o sostenerle a piè di lista, ma intervenire su una progettualità per rendere sostenibili le fondazioni culturali nate dalla trasformazione giuridica di enti pubblici.
La «Carta delle fondazioni» dà linee guida sulla loro identità.
E’ una buona traccia su cui sviluppare una progettualità comune. Ed è positivo che sia un atto volontario, perché un eccesso di prescrizione rischia solo di generare ottemperanza formale. Il processo di costruzione e di condivisione della Carta attraverso un percorso lungo e articolato va nella direzione di orientare le fondazioni verso la riflessione strategica, verso la determinazioni di obiettivi chiari, segnando la separazione tra fondazioni e politica, sviluppando competenze interne, costruendo protocolli e azioni non basati esclusivamente sulla sensibilità o capacità del Presidente di turno. Si tratta ora di creare continue occasioni di verifiche e di chiedere massima trasparenza nei processi, con seria autocritica, aprendo il tavolo a livello nazionale, con le amministrazioni pubbliche, portandole a mettere a tema la questione di cosa significhi fare le politiche in questo Paese e di cosa questo Paese abbia bisogno. La mia sensazione è che i soldi non sono il bisogno fondamentale. C’è invece la forte esigenza di ridurre e razionalizzare la spesa eliminando gli sprechi. Il ruolo delle Fondazioni non deve essere quello di mettere risorse su vecchi problemi. C’è la necessità di ripensare le politiche del Paese. Su questo le FOB hanno una grossa opportunità e responsabilità, perché hanno possibilità che ad altri soggetti è preclusa.
© Riproduzione riservata
Gianpaolo Barbetta è Professore di Economia dei sistemi di welfare presso l’Università Cattolica di Milano e responsabile dell’Unità strategica per la filantropia della Fondazione Cariplo
(dal XII Rapporto Annuale Fondazioni)