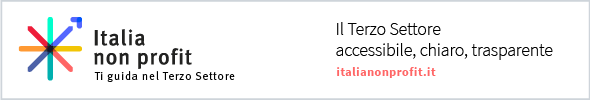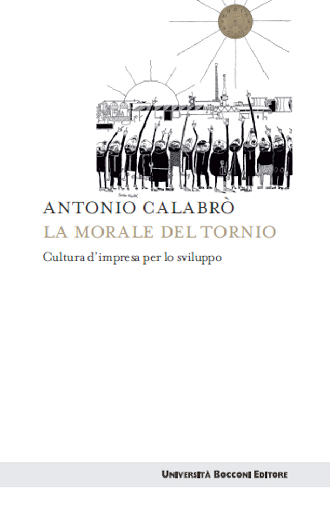La morale del tornio
L’ultimo libro di Antonio Calabrò, consigliere delegato della Fondazione Pirelli e responsabile Cultura di Confindustria, è un elogio dell’economia reale e un invito al recupero della centralità dell’impresa industriale, in cui il saper fare e il saper raccontare sono parte di un comune processo di rinnovamento che ha per tema la qualità delle aziende manifatturiere, e le nicchie di mercato ad alto valore aggiunto che producono cultura.
Il titolo del libro, La morale del Tornio. Cultura d’impresa per lo sviluppo, pubblicato da Università Bocconi Editore, parte da una battuta di Giulio Tremonti: c’è più moralità in un tornio che in un certificato di una banca d’affari. L’economia di carta, effimera, sembra avere una sua controparte nelle «fabbriche di carta», per riprendere il titolo d’una bella antologia sulla letteratura industriale, curata da Giorgio Bigatti e Giuseppe Lupo, pubblicata da Laterza e sostenuta da Assolombarda: ovvero nella scrittura che dà voce all’impresa e ne racconta attività e senso. Che cosa mostrano queste due polarità? Ne parliamo con l’autore.
Rivelano storie molto diverse. L’economia di carta non ha creato nessuna narrazione duratura, ha solo dato vita al modello negativo dell’imprenditore speculativo, ossessionato dal denaro, che ha bisogno dell’ombra per nascondere il suo operato, che il cinema su Wall Street e le sue rapacità, più che la letteratura, ha saputo mettere in scena. La «fabbrica di carta» racconta invece gli imprenditori positivi, i tecnici, gli operai, quelli che fabbricano e che sporcandosi le mani hanno il piacere e la voglia di mostrarsi in prima persona e di essere raccontati. Questi ultimi hanno a che fare con l’impresa luminosa, con la fabbrica «bella», architettonicamente innovativa, ambientalmente rispettosa dei territori e delle persone. Competitività, appunto, come sostenibilità. Ma anche come legalità, secondo culture di mercato aperte, trasparenti, ben regolate.
Nel percepito della gente ancora oggi la fabbrica è sporca e cattiva. Nel libro su «La morale del tornio» si sostiene più volte, invece, che le fabbriche ci salveranno. Quale modello ha in mente?
Parlo delle neofabbriche, quelle nate nel segno del quarto capitalismo, di dimensioni medie, dedite al manifatturiero e con forte vocazione internazionale. Sono queste le aziende belle, sostenibili, efficienti, che avendo a cuore l’estetica e l’etica esprimono il potere trasformativo della cultura d’impresa. Nel libro mi propongo di dare voce e rappresentazione alle aziende medium tech, come le ha ben definite Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, colmando un deficit di narrazione che non riesce a far passare la forza innovativa di queste realtà. Una innovazione che riguarda tutto il Paese e chiede anche scelte di politica industriale e culturale. Di recente, Confindustria, Symbola, il Fai e il Touring si sono incontrati con il ministro della Cultura Franceschini proprio per definire strumenti in grado di sostenere questo tipo di impresa, e di far dialogare pubblico e privato, imprese, associazioni ambientaliste e mondo del turismo, in quanto agenti di sviluppo economico ed espressioni di comunità e di salvaguardia del territorio di appartenenza.
Per descrivere queste aziende fa riferimento a comunità di matrice olivettiana e culture d’impresa caratteristiche della storia e dell’attualità di Pirelli, e racconta l’evoluzione di un nuovo connubio: territorio e cultura digitale. Prossimità e reti lunghe.
Cambiano le modalità di interazione e di scambio ma, a ben guardare, la tradizione italiana ha alla base proprio le catene lunghe di manifattura e commerci, in cui l’oggetto prodotto era venduto su piazze internazionali, accompagnato da tutta una serie di servizi finanziari e commerciali, fatture, lettere di cambio, libri di navigazione, assicurazioni. Basti pensare storicamente ai tessuti veneziani e genovesi, alle maioliche di Faenza, che già nel Medioevo e nel Rinascimento erano riconosciuti come espressione di artigianalità ed eccellenza, emblema del Made in Italy. Il valore aggiunto di quelle produzioni era dato dagli artigiani, dagli stessi commercianti, che avevano nella mente la bellezza dei territori da cui provenivano. Il nostro paese, come scrive lo storico Carlo Maria Cipolla, «è abituato, fin dal Medioevo, a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo». Le reti delle relazioni contemporanee, fisiche e digitali, non fanno che amplificare e rafforzare un fenomeno che era già italiano, quello di mettere insieme competenze diverse per rispondere al meglio alle richieste dei mercati.
Nel libro si parla spesso di Reshoring. Di imprese «salmone» che tornano a produrre in Italia. Come si spiega questo fenomeno?
E’ sempre più evidente che noi italiani possiamo competere esclusivamente in nicchie altamente specializzate e di qualità, ad alto valore aggiunto. La nostra tradizione manifatturiera non ha degli equivalenti in altri paesi e i tentativi di delocalizzazione delle produzioni hanno detto spesso dei risultati scadenti. Le aziende hanno compreso che non si può rinunciare al territorio e a competenze secolari. Ecco perché molte imprese stanno tornando a produrre in Italia. Non solo nel mondo della moda, ma anche in quello della meccanica e di altri settori medium e hi tech. Torna anche l’industria della concia, che ha dovuto fare un vero e proprio upgrade tecnologico per rendere ecologici e sostenibili i processi produttivi e fornire, all’industria del lusso, pellami sofisticati adatte alle borse di gran lusso, il cui livello d’eccellenza è garantito solo da una manifattura d’altissima qualità. Italiana, appunto. Una vera rivoluzione nel settore, che ben racconta quanto il tema della responsabilità d’impresa sia cruciale per l’immagine aziendale, che il mercato riconosce e premia.
Se «i mercati sono conversazioni», come affermava già nel Settecento l’abate Ferdinando Galiani, il tema della reputazione sta assumendo per l’impresa un ruolo sempre più importante.
Il mercato, contrariamente a quello che si pensa in certi ambienti, ha una sua moralità. A differenza del passato, c’è un maggiore controllo che permette dei correttivi impensabili sino a qualche tempo fa. E fa crescere il senso di responsabilità delle imprese. Penso al caso della Barilla, all’infelice battuta di Guido Barilla sul privilegio delle famiglia tradizionale, alle reazioni polemiche e alla tempestiva risposta del gruppo, che fa sì che proprio la Barilla, preso atto dell’errore di comunicazione, sia diventata sostenitrice della salvaguardia dei diritti “lgtb” (lesbian, gay, transgender, bisexual). Un positivo cambiamento di rotta, per rispettare sensibilità diffuse sul mercato. Il risultato positivo è la spinta al rinnovamento. Come ha sostenuto il premio Nobel Gary S. Becker, escludere non solo è immorale, ma non conviene: è antieconomico perché taglia fuori talenti senza motivazioni reali ma solo pregiudizialmente discriminatorie, non premia il merito e non rappresenta la complessità in cui viviamo.
Cultura politecnica, sintesi di umanesimo e scienza è un po’ il mantra del libro. Come si coniugano questi due mondi?
Sono mondi che storicamente hanno sempre dialogato e che durante il corso del Novecento, però, sono stati spesso percepiti come separati. Lo stesso modello americano, che ha fatto della specializzazione tecnica la sua forza, sta tornando sui suoi passi, introducendo letteratura, filosofia e teatro nella formazione economica. E da noi non mancano esempi in questa direzione. L’esperienza di Olivetti, di Pirelli, già agli inizi del XX secolo ci restituisce l’importanza di far entrare in azienda artisti, letterati, poeti e di farli dialogare con tecnici e scienziati, di costruire processi di collaborazione. Basti pensare a una figura chiave come Leonardo Sinisgalli, il poeta matematico alla direzione della Rivista Pirelli e poi di “Civiltà delle macchine” dell’Iri. Il Politecnico di Milano e di Torino hanno già inserito le materie umanistiche nei propri piani di studio. Il futuro, insomma, è degli ingegneri filosofi.
Il manager capace, pronto a sfidare la complessità e la globalizzazione, deve nutrirsi di buone letture. E l’artista che cosa può imparare dall’impresa? In Italia l’esperienza in azienda per il momento non sembra dare alcun credito formativo.
Storicamente l’artista è sempre stato politecnico. Le grandi invenzioni vengono dal dialogo tra arte, matematica, fisica, chimica, dagli scambi e dagli incroci di saperi. La nascita della prospettiva si deve a Piero della Francesca che non a caso era anche un eccellente matematico. Il “rosso Tiziano” è il risultato di ricerche sui colori effettuate dall’artista e dalla sua bottega, che altro non era che una piccola fabbrica, dove si sperimentava con la luce, i colori, i materiali. In fondo, anche oggi, ci sono artisti che dimostrano di conoscere la fisica, la chimica, la tecnologia e le usano come strumenti per la creatività. Lo studio del processo produttivo, dei materiali, dell’utilizzo della tecnologia in ambito aziendale è un campo di esplorazione a disposizione degli artisti. L’esperienza delle mostre prodotte dalla Fondazione Hangar Bicocca che ha fatto dialogare artisti e tecnici della Pirelli sui temi più disparati (dalle nanotecnologie ai laser, dai processi produttivi della gomma alle potenzialità estetiche e funzionali dei materiali più innovativi), dimostra che l’incontro è possibile e proficuo. Anche in questo settore occorre creare collegamenti tra luoghi formativi e impresa.
La relazione tra impresa e cultura spesso avviene sotto forma di mecenatismo, o di ornamento. Quali i possibili correttivi?
Per una strana distorsione ottica, spesso non si leggono i punti di contatto tra impresa e cultura. La cultura è un dato profondo che necessita di tempi lunghi, che si basa su relazioni umane, sulla costruzione di comunità non diversamente dall’impresa industriale che, per sua natura, non può essere effimera e deve nutrirsi di realtà, di storie e di persone vere. La stessa cultura non è solo un romanzo, un quadro o un’opera per un quartetto d’archi, ma è una visione della creatività, spesso sottotraccia, che si costruisce con fatica, si porta alla luce, si diffonde. E’ un duro lavoro. Così come l’impresa non è fatta solo dall’imprenditore ma è il racconto articolato di più voci: imprenditori, operai, tecnici, dirigenti, fornitori, clienti, luoghi di produzione e territori di mercato. Cultura e impresa devono saper intercettare e articolare il racconto di tante voci, dando una forma in grado di parlare a pubblici nuovi con linguaggi differenti. Non è sufficiente invitare un’artista a interpretare l’impresa se non si toccano dei contenuti veri e profondi. La stessa comunicazione d’impresa delle aziende storiche del Novecento, come Pirelli appunto, era affidata ai migliori artisti e designer dell’epoca (Bruno Munari, Bob Noorda, Alessandro Mendini, etc.), che volutamente adottavano un linguaggio innovativo ma contemporaneamente popolare, allineato ai contenuti di valore che volevano trasmettere. Ritorniamo ancora una volta al tema della qualità: qualità della produzione e del racconto. Saper fare e saper raccontare.
Nel libro fa riferimento a una cultura nazionalpopolare che stride con l’idea della cultura come processo riservato alle élite.
Credo che sia una distorsione contemporanea il pensare che la qualità sia per pochi. L’esperienza della musica classica nella fabbrica Pirelli di Settimo Torinese e la risposta entusiasta del pubblico, la cui metà era composta da dipendenti e dai loro familiari, ci dice che bisogna avere uno sguardo ampio, appunto popolare. L’élite, a mio parere, è concepibile solo come espressione di persone dotate di più strumenti e visioni che devono sapere ricercare, sperimentare in piena libertà ma anche sentirsi responsabili verso le comunità, con la capacità di costruire mostre, spettacoli teatrali, concerti di qualità per pubblici ampi, esigenti, curiosi.
Lei afferma che senza manifattura non ci sono servizi e che nei territori dove operano aziende di qualità aumentano le produzioni culturali. Il legame si fa sempre più stretto.
C’è un indotto che viene descritto chiaramente nel libro di Enrico Moretti, La Nuova geografia del lavoro, in cui per ogni posto di lavoro ad alto contenuto tecnologico se ne generano altri cinque legati ai servizi all’impresa e alla persona. Inoltre, per essere competitivi oggi prodotti e mercati devono conoscere i linguaggi contemporanei. Impresa e cultura hanno bisogno di un comune denominatore: ricerca, innovazione, formazione, e inclusione delle differenze.
Dalla zuppa del demonio alla manufacturing renaissance .Quale futuro ci attende?
Il bel documentario di Davide Ferrario, Zuppa del demonio, titolo preso in prestito dalla definizione di Dino Buzzati, per descrivere la colata di acciaio fuso dell’Italsider, racconta la forza e l’evocatività della grande fabbrica del Novecento (Ansaldo, Fiat, Olivetti, Eni, Pirelli) e delle dinastie industriali, che oggi non esistono più. Un passato che ha una forma e un’estetica precisa costruita sull’immagine delle tute blu degli operai. Oggi l’impresa ha un nuovo volto. E’ fatta di colletti bianchi, camici di ricercatori, abiti casual ed è segnata da produzioni digitali, impianti ad alta automazione, laboratori di ricerca ed energia pulita. E’ un luogo da visitare e da mostrare agli studenti, dando forma e voce all’impresa di qualità. Memoria consapevole e futuro responsabile è oggi l’unica via.
Nello scenario tracciato nel libro l’arte, la musica e il teatro devono entrare in fabbrica e il lavoro deve diventare materia per il teatro. Qualche suggerimento?
Un’anticipazione. La prossima Settimana della Cultura d’Impresa, organizzata da in novembre da Confidustria e da Museimpresa, sarà dedicata a “L’impresa va in scena”, in collaborazione tra aziende e teatri, in molte città italiane: verranno letti e interprati alcuni brani tratti dall’antologia La Fabbrica di carta, dedicata al rapporto tra letteratura e industria. Il teatro ha la capacità di parlare a tutti, ed è questo il punto di vista che ci interessa adottare. Uno sguardo volutamente popolare.
© Riproduzione riservata