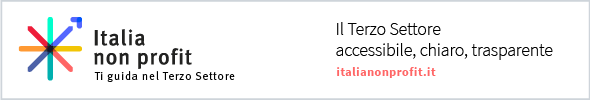Il lago che scompare. Cave dell’invisibile
Autore/i:
Rubrica:
PAESAGGI
Articolo a cura di:
Luca Dal Pozzolo
La manutenzione decennale che comporta lo svuotamento del Lago di Molvena è una ferita per la popolazione. Un progetto artistico, partecipato, multidimensionale, commissionato con il concorso interistituzionale s-vela e ri-vela un nuovo senso collettivo. Trasformando l’evento in una opportunità. E’ il potere dell’Arte, Bellezza!
“(…) eccellenza, siamo alla curva finale, o vengono i fanti o ci portiamo via il mare, non c’è altra scelta, eccellenza, non ce n’era un’altra, madre, di modo che si portarono via i Caraibi in aprile, se lo portarono via in pezzi numerati gli ingegneri nautici dell’ambasciatore Ewing per seminarlo lontano dagli uragani nelle aurore di sangue dell’Arizona, se lo portarono via con tutto quello che aveva dentro, signor generale, col riflesso delle nostre città, coi nostri annegati timidi, coi nostri draghi dementi (…)”
Gabriel Garcia Marquez, l’Autunno del Patriarca
Negli anni ’20 nacque l’idea di uno sfruttamento razionale dell’alto e del medio bacino del fiume Sarca al fine di produrre energia elettrica. Il progetto più ambizioso venne redatto nel 1925. Si trattava di un’opera ciclopica che non aveva precedenti in Europa. Nel 1946 cominciarono i lavori con la realizzazione di una serie di condotte per convogliare nel Lago di Molvena le acque dei bacini dell’Adamello e del Brenta orientale. Il lago con una capacità di 234 milioni di metri cubi avrebbe sempre assicurato il funzionamento delle potenti turbine della centrale di Santa Massenza, destinata a diventare la più grande d’Europa. Entrò in funzionamento dal 1952.
A cadenza decennale è necessaria la manutenzione delle condotte. Per questo motivo nell’inverno 2016/2017 il lago è stato abbassato di 80 metri, per tornare a giugno alla consueta quota.
Nell’intento di trasformare in opportunità questo evento vissuto dalla comunità come una ferita, l’Amministrazione comunale, in rete con altri soggetti, ha incaricato il collettivo di artisti OP di realizzare un progetto ruotando intorno all’analogia svuotamento/riempimento con le operazioni ai bambini affetti da cardiopatia congenita effettuate dai chirurghi dell’Associazione Bambini Cardiopatici del Mondo. I loro cuori vengono temporaneamente fermati, il flusso di sangue deviato verso vasi artificiali e, una volta operati, si stabilisce una normale circolazione dei fluidi che li restituisce alla vita.
Il lago è nel contempo prezioso per la sua bellezza e per la produzione di energia pulita e sana. L’operazione al suo “cuore” è un modo per garantire la convivenza del bisogno energetico con la straordinarietà di una natura che ci è stata affidata in perfetta salute.
L’intervento artistico è divenuto il modo per comprendere il valore di questa operazione specifica e delle tante altre che potrebbero, se adeguatamente gestite, contribuire a ridurre il debito entropico che abbiamo contratto con il Pianeta.
Gli elementi dell’opera, in un processo partecipato, sono stati molteplici e hanno contribuito a cambiare il “punto di vista”: il Manifesto poetico di Alessandro Cremonesi, il Tavolo palcoscenico dell’interazione, la Capsula del Tempo, il Paesaggio Sonoro, la Scultura Monumentale.
Il Tavolo, ideato da Thomas Bohm e Luca Lagash, della lunghezza di 100 metri, realizzato con il legno delle segherie di Molveno, è stato installato sulle sponde del lago per permettere a cittadini e turisti di innescare meccanismi di socialità con programmi che si sono ramificati nei luoghi della cultura del Trentino, al Mart di Rovereto e al MUSE di Trento.
Accanto al Tavolo è stato posato uno scrigno per contenere i pensieri, le immagini, gli appunti dei residenti e dei visitatori.
Il Paesaggio sonoro di Luca Lagash è un percorso onirico di suoni e composizioni colto a svelare la voce sepolta del Lago che è andato in onda su una superfice di 25mila metri, 24 h su 24, per due mesi.
MOG, Morgana Orsetta Ghini ha rappresentato il lago, spogliato dalle acque, in verticale, in acciaio; una scultura che ricorda ai residenti che il lago è sempre il Lago, anche se appare diverso ed evoca il dialogo tra montagna maestosa e le acque increspate dal vento.
Una storia di identità di comunità, di ri-significazione, di senso collettivo che ha visto uniti in una collaborazione istituzionale il Comune di Molveno, l’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda di Promozione turistica Dolomiti Paganella e la Trento School of Management.
Vi proponiamo la prefazione al catalogo di Luca Dal Pozzolo.
***
Era già successo, quando il vecchio Patriarca aveva ceduto il mare e non restava che contemplare attoniti la pianura deserta di aspra polvere lunare, gli sterpeti di balani laddove un tempo si adagiava un fondale caraibico, e anche qui, di fronte all’immensa cavea denudata delle sue trasparenti profondità noi ci chiedevamo se ci saremmo mai abituati a quella vista, se vi avremmo mai riconosciuto nuovamente un paesaggio, e in molti pensavamo che no, sebbene qualcosa ci dicesse che forse sì, un giorno ci saremmo di nuovo sentiti a casa, forse, perché quell’invaso grigio che compariva per l’inesorabile emorragia turchese, inciso da curve di livello degradanti, come larghe e ordinate rughe nella pelle millenaria di elefante, ci costringeva a torcere lo sguardo al fondo del nostro stesso occhio, oltre al cristallino, fino a scansire le retine e il loro brulicare lampeggiante, a risalire il senso delle nostre immagini, lì dove si formano, dove l’occhio si adatta al ruolo di gregario pigro per alimentare le nostre inerzie, a fornire viste ossequiose alle nostre attese, anche perché ci ronzava nelle orecchie quella battuta di Oscar Wilde, che diceva come non ci fosse nebbia a Londra prima che Whistler la dipingesse, come fosse suo il copyright della nebbia, non del vapore acqueo in sospensione, ovvio, ché quello naturalmente preesisteva, ma della nebbia in quanto tale, come velatura del visibile, ostruzione al paesaggio, in grado di sfuggire al registro dell’immagine, fino a quando non arrivò ‘sto pittore eccentrico a dirci ma guardate bene, ché la nebbia non è mica un accidente e se non intuite i trafori neogotici del Parlamento è perché la nebbia è la cifra del paesaggio, cazzo, ma come fate a non vedere?, e non a caso era un pittore e anche noi sentivamo di aver un forte bisogno di qualcuno che producesse qualcosa di bello, per risarcire il nostro senso di perdita, che fluiva via gorgogliando in vortici turchesi, cancellando il nostro doppio, perché solo oggi ci accorgevamo di aver conservato l’ombra, ma di essere dolorosamente orfani del riflesso, di quel gemello che camminava con noi a testa in giù, lungo la riva e la schiera delle nostre case, anch’esse rovesciate, appena tremanti per l’increspatura della superficie, e però pensavamo a una consolazione, perché come dice un filosofo di cui non ricordo il nome, è l’acqua l’occhio della terra, ed è l’acqua che sogna nei nostri occhi, per questo pensavamo a qualcosa che lenisse il vuoto del nostro sguardo, l’evaporare dei nostri sogni, per questo non osavamo desiderare di più, ed è sempre per questo che quando gli artisti vennero, all’inizio, ci sembrava facessero poco, perché qualsiasi cosa era poca cosa di fronte alla vastità dell’acqua che si ritirava e alla distesa grigia che si dispiegava, ora triste e dura nel cretto di fanghi rappresi, ora argentea come la livrea di un luccio, se solo i raggi di luce foravano la coltre di nubi, e persino quel tavolo che serpeggiava per cento metri, era lunghissimo, certo, e ci potevamo sedere su di una scheggia di luogo, un frammento di presenza umana in quella distesa inospitale, ma la coltre di sabbie ci faceva sentire così piccoli e soli come non fummo mai quando c’erano le acque, e la scultura, anche quella, sebbene alta assai, lo era solo da vicino, poi si restringeva in modo anomalo appena a pochi passi e la musica che tornava dalle rive subito pareva un riverbero di naufragio che non ci avrebbe liberato delle nostre tristezze, eppure presto scoprimmo che i frammenti sonori componevano una voce, anzi un canone a molte voci perché mai ci eravamo chiesti come il lago parlasse allo stesso tempo ai salmerini, ai pesci persici, alle tinche, come sussurrasse alle alghe pettinandole alla corrente, come si lamentasse tra il fasciame aperto delle barche affondate, quando parlasse a scatti e grugniti futuristi, trak–zabum-krrr alle turbine che cavitavano nelle sue viscere, come consolasse gli animali affogati in acque ormai antiche, ed erano proprio voci salmodianti nella lingua liquida del lago e noi le ascoltavamo per la prima volta, con lo smarrimento di una rivelazione, intuendo una calligrafia di volute e arabeschi, giacché le sentivamo appena modularsi nel timbro scuro di gorghi lenti e distesi, occupare in volute barocche l’invaso vuoto, allagando di un canone arcano la scala dei diversi livelli incisi nella geologia delle sponde, fino a immergerci in un’aria vibrante, a galleggiare nel lascito invisibile di un’acqua irrimediabilmente altrove; così in verità non sappiamo proprio dire quale sia stato il momento in cui capimmo che gli artisti non stavano lavorando a inseguire il lago che spariva, che l’avevano lasciato andare senza esitazioni e senza rimpianti, ché già noi ne avevamo accumulati abbastanza, di rimpianti, voglio dire, no, non era quella la loro tela, ma solo il fondale che li ospitava mentre lavoravano sul nostro sguardo, dietro ai nostri cristallini, dietro alle nostre retine per modificare le nostre attese esistenziali, per modificarne il senso a un punto tale, che quei pochi piccoli segni, il serpentone del tavolo, il riverbero dei suoni, il salmodiare di quella lingua arcana, i volumi scolpiti, pur sovrastati dal dispiegarsi del vuoto, potessero diventare appigli per lo sguardo, per costruire un nuovo senso, non di mancanza, non di assenza, ma di un altrove, proprio qui, dove nel frattempo ci stava crescendo con prepotenza un nuovo paesaggio sotto i piedi, perché l’opera c’era già tutta nella sua maestosità, nel ritirarsi delle acque, nella forza tellurica delle orografie denudate e nell’apparire di una geografia segreta e profonda, capace di ospitare l’immensità dei nostri immaginari, se solo fossimo stati capaci d’intuirne fin dall’inizio la presenza, ma che non avremmo visto, che avremmo pensato come assenza, un cratere desolato, come una violenta privazione, se gli artisti con quei segni, pur piccoli e delicati, non ci avessero convinti a trovare un paesaggio profondo come la nostra anima, a vedere ciò che dinanzi a noi, solo poco prima, non potevamo vedere, come una macchia scura e assente al centro della visione, perché alla fine è questo quello che fanno gli artisti, si piazzano lì, sul confine tra visibile e invisibile e cavano dall’invisibile metricubi e metricubi di detriti e di minerale immaginario, che portano qui, da questa parte del visibile, perché possiamo vedere anche noi, sicché rare volte siamo toccati da quella grazia del saper vedere, più spesso ci vogliono decenni perché riusciamo a percepire ciò che gli artisti ci hanno regalato dalle cave dell’invisibile, ma quando ci riusciamo, cascasse il mondo, cazzo, non ce lo perdiamo più, neanche se le acque ritornano a primavera a rioccupare la cavea abbandonata e a restituirci i riflessi sequestrati dall’arsura, a inondarci nuovamente di turchese e trasparenze, perché noi, proprio qui, abbiamo visto emergere un altrove popolato di figurini colorati come minuscoli pattinatori di un quadro fiammingo, file di persone a istoriare d’impronte la cedevolezza delle sabbie come un grande tatuaggio sul viso nascosto del lago e aquiloni e colori brulicanti e a tal punto adesso tutto questo ci appartiene che ogni tanto si pensa a come sarà in futuro un altro svuotamento, quasi si fosse inaugurato un ciclo vitale di respirazione acquea, quali paesaggi potremmo nuovamente scoprire, quando sentiremo ancora quella voce ora inabissata insieme ai salmerini, a quale tavolo potremo nuovamente appoggiare i gomiti, reggerci il mento nelle mani e affondare lo sguardo nella profondità del paesaggio, da questo lato della pelle, dritto dentro di noi.
© Riproduzione riservata
A cadenza decennale è necessaria la manutenzione delle condotte. Per questo motivo nell’inverno 2016/2017 il lago è stato abbassato di 80 metri, per tornare a giugno alla consueta quota.
Nell’intento di trasformare in opportunità questo evento vissuto dalla comunità come una ferita, l’Amministrazione comunale, in rete con altri soggetti, ha incaricato il collettivo di artisti OP di realizzare un progetto ruotando intorno all’analogia svuotamento/riempimento con le operazioni ai bambini affetti da cardiopatia congenita effettuate dai chirurghi dell’Associazione Bambini Cardiopatici del Mondo. I loro cuori vengono temporaneamente fermati, il flusso di sangue deviato verso vasi artificiali e, una volta operati, si stabilisce una normale circolazione dei fluidi che li restituisce alla vita.
Il lago è nel contempo prezioso per la sua bellezza e per la produzione di energia pulita e sana. L’operazione al suo “cuore” è un modo per garantire la convivenza del bisogno energetico con la straordinarietà di una natura che ci è stata affidata in perfetta salute.
L’intervento artistico è divenuto il modo per comprendere il valore di questa operazione specifica e delle tante altre che potrebbero, se adeguatamente gestite, contribuire a ridurre il debito entropico che abbiamo contratto con il Pianeta.
Gli elementi dell’opera, in un processo partecipato, sono stati molteplici e hanno contribuito a cambiare il “punto di vista”: il Manifesto poetico di Alessandro Cremonesi, il Tavolo palcoscenico dell’interazione, la Capsula del Tempo, il Paesaggio Sonoro, la Scultura Monumentale.
Il Tavolo, ideato da Thomas Bohm e Luca Lagash, della lunghezza di 100 metri, realizzato con il legno delle segherie di Molveno, è stato installato sulle sponde del lago per permettere a cittadini e turisti di innescare meccanismi di socialità con programmi che si sono ramificati nei luoghi della cultura del Trentino, al Mart di Rovereto e al MUSE di Trento.
Accanto al Tavolo è stato posato uno scrigno per contenere i pensieri, le immagini, gli appunti dei residenti e dei visitatori.
Il Paesaggio sonoro di Luca Lagash è un percorso onirico di suoni e composizioni colto a svelare la voce sepolta del Lago che è andato in onda su una superfice di 25mila metri, 24 h su 24, per due mesi.
MOG, Morgana Orsetta Ghini ha rappresentato il lago, spogliato dalle acque, in verticale, in acciaio; una scultura che ricorda ai residenti che il lago è sempre il Lago, anche se appare diverso ed evoca il dialogo tra montagna maestosa e le acque increspate dal vento.
Una storia di identità di comunità, di ri-significazione, di senso collettivo che ha visto uniti in una collaborazione istituzionale il Comune di Molveno, l’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda di Promozione turistica Dolomiti Paganella e la Trento School of Management.
Vi proponiamo la prefazione al catalogo di Luca Dal Pozzolo.
***
Era già successo, quando il vecchio Patriarca aveva ceduto il mare e non restava che contemplare attoniti la pianura deserta di aspra polvere lunare, gli sterpeti di balani laddove un tempo si adagiava un fondale caraibico, e anche qui, di fronte all’immensa cavea denudata delle sue trasparenti profondità noi ci chiedevamo se ci saremmo mai abituati a quella vista, se vi avremmo mai riconosciuto nuovamente un paesaggio, e in molti pensavamo che no, sebbene qualcosa ci dicesse che forse sì, un giorno ci saremmo di nuovo sentiti a casa, forse, perché quell’invaso grigio che compariva per l’inesorabile emorragia turchese, inciso da curve di livello degradanti, come larghe e ordinate rughe nella pelle millenaria di elefante, ci costringeva a torcere lo sguardo al fondo del nostro stesso occhio, oltre al cristallino, fino a scansire le retine e il loro brulicare lampeggiante, a risalire il senso delle nostre immagini, lì dove si formano, dove l’occhio si adatta al ruolo di gregario pigro per alimentare le nostre inerzie, a fornire viste ossequiose alle nostre attese, anche perché ci ronzava nelle orecchie quella battuta di Oscar Wilde, che diceva come non ci fosse nebbia a Londra prima che Whistler la dipingesse, come fosse suo il copyright della nebbia, non del vapore acqueo in sospensione, ovvio, ché quello naturalmente preesisteva, ma della nebbia in quanto tale, come velatura del visibile, ostruzione al paesaggio, in grado di sfuggire al registro dell’immagine, fino a quando non arrivò ‘sto pittore eccentrico a dirci ma guardate bene, ché la nebbia non è mica un accidente e se non intuite i trafori neogotici del Parlamento è perché la nebbia è la cifra del paesaggio, cazzo, ma come fate a non vedere?, e non a caso era un pittore e anche noi sentivamo di aver un forte bisogno di qualcuno che producesse qualcosa di bello, per risarcire il nostro senso di perdita, che fluiva via gorgogliando in vortici turchesi, cancellando il nostro doppio, perché solo oggi ci accorgevamo di aver conservato l’ombra, ma di essere dolorosamente orfani del riflesso, di quel gemello che camminava con noi a testa in giù, lungo la riva e la schiera delle nostre case, anch’esse rovesciate, appena tremanti per l’increspatura della superficie, e però pensavamo a una consolazione, perché come dice un filosofo di cui non ricordo il nome, è l’acqua l’occhio della terra, ed è l’acqua che sogna nei nostri occhi, per questo pensavamo a qualcosa che lenisse il vuoto del nostro sguardo, l’evaporare dei nostri sogni, per questo non osavamo desiderare di più, ed è sempre per questo che quando gli artisti vennero, all’inizio, ci sembrava facessero poco, perché qualsiasi cosa era poca cosa di fronte alla vastità dell’acqua che si ritirava e alla distesa grigia che si dispiegava, ora triste e dura nel cretto di fanghi rappresi, ora argentea come la livrea di un luccio, se solo i raggi di luce foravano la coltre di nubi, e persino quel tavolo che serpeggiava per cento metri, era lunghissimo, certo, e ci potevamo sedere su di una scheggia di luogo, un frammento di presenza umana in quella distesa inospitale, ma la coltre di sabbie ci faceva sentire così piccoli e soli come non fummo mai quando c’erano le acque, e la scultura, anche quella, sebbene alta assai, lo era solo da vicino, poi si restringeva in modo anomalo appena a pochi passi e la musica che tornava dalle rive subito pareva un riverbero di naufragio che non ci avrebbe liberato delle nostre tristezze, eppure presto scoprimmo che i frammenti sonori componevano una voce, anzi un canone a molte voci perché mai ci eravamo chiesti come il lago parlasse allo stesso tempo ai salmerini, ai pesci persici, alle tinche, come sussurrasse alle alghe pettinandole alla corrente, come si lamentasse tra il fasciame aperto delle barche affondate, quando parlasse a scatti e grugniti futuristi, trak–zabum-krrr alle turbine che cavitavano nelle sue viscere, come consolasse gli animali affogati in acque ormai antiche, ed erano proprio voci salmodianti nella lingua liquida del lago e noi le ascoltavamo per la prima volta, con lo smarrimento di una rivelazione, intuendo una calligrafia di volute e arabeschi, giacché le sentivamo appena modularsi nel timbro scuro di gorghi lenti e distesi, occupare in volute barocche l’invaso vuoto, allagando di un canone arcano la scala dei diversi livelli incisi nella geologia delle sponde, fino a immergerci in un’aria vibrante, a galleggiare nel lascito invisibile di un’acqua irrimediabilmente altrove; così in verità non sappiamo proprio dire quale sia stato il momento in cui capimmo che gli artisti non stavano lavorando a inseguire il lago che spariva, che l’avevano lasciato andare senza esitazioni e senza rimpianti, ché già noi ne avevamo accumulati abbastanza, di rimpianti, voglio dire, no, non era quella la loro tela, ma solo il fondale che li ospitava mentre lavoravano sul nostro sguardo, dietro ai nostri cristallini, dietro alle nostre retine per modificare le nostre attese esistenziali, per modificarne il senso a un punto tale, che quei pochi piccoli segni, il serpentone del tavolo, il riverbero dei suoni, il salmodiare di quella lingua arcana, i volumi scolpiti, pur sovrastati dal dispiegarsi del vuoto, potessero diventare appigli per lo sguardo, per costruire un nuovo senso, non di mancanza, non di assenza, ma di un altrove, proprio qui, dove nel frattempo ci stava crescendo con prepotenza un nuovo paesaggio sotto i piedi, perché l’opera c’era già tutta nella sua maestosità, nel ritirarsi delle acque, nella forza tellurica delle orografie denudate e nell’apparire di una geografia segreta e profonda, capace di ospitare l’immensità dei nostri immaginari, se solo fossimo stati capaci d’intuirne fin dall’inizio la presenza, ma che non avremmo visto, che avremmo pensato come assenza, un cratere desolato, come una violenta privazione, se gli artisti con quei segni, pur piccoli e delicati, non ci avessero convinti a trovare un paesaggio profondo come la nostra anima, a vedere ciò che dinanzi a noi, solo poco prima, non potevamo vedere, come una macchia scura e assente al centro della visione, perché alla fine è questo quello che fanno gli artisti, si piazzano lì, sul confine tra visibile e invisibile e cavano dall’invisibile metricubi e metricubi di detriti e di minerale immaginario, che portano qui, da questa parte del visibile, perché possiamo vedere anche noi, sicché rare volte siamo toccati da quella grazia del saper vedere, più spesso ci vogliono decenni perché riusciamo a percepire ciò che gli artisti ci hanno regalato dalle cave dell’invisibile, ma quando ci riusciamo, cascasse il mondo, cazzo, non ce lo perdiamo più, neanche se le acque ritornano a primavera a rioccupare la cavea abbandonata e a restituirci i riflessi sequestrati dall’arsura, a inondarci nuovamente di turchese e trasparenze, perché noi, proprio qui, abbiamo visto emergere un altrove popolato di figurini colorati come minuscoli pattinatori di un quadro fiammingo, file di persone a istoriare d’impronte la cedevolezza delle sabbie come un grande tatuaggio sul viso nascosto del lago e aquiloni e colori brulicanti e a tal punto adesso tutto questo ci appartiene che ogni tanto si pensa a come sarà in futuro un altro svuotamento, quasi si fosse inaugurato un ciclo vitale di respirazione acquea, quali paesaggi potremmo nuovamente scoprire, quando sentiremo ancora quella voce ora inabissata insieme ai salmerini, a quale tavolo potremo nuovamente appoggiare i gomiti, reggerci il mento nelle mani e affondare lo sguardo nella profondità del paesaggio, da questo lato della pelle, dritto dentro di noi.
© Riproduzione riservata