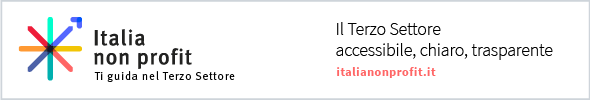Epistole su Brera
Capranica (VT), 31 agosto 2012
Egregio Presidente Bassetti,
la recente normativa (legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 8) che ha disposto la costituzione della fondazione incaricata di gestire la Pinacoteca nazionale di Brera ha suscitato interesse e scalpore, consensi - scarsi e cauti - ed aperti dissensi, soprattutto sul modo in cui è stata elaborata e promulgata; ma, a quanto ne so, poche o assenti sono le proposte alternative concrete, forse anche perché molti elementi utili ad una valutazione obiettiva della nuova normativa su Brera non sono stati ancora prodotti o non sono attualmente di dominio pubblico. Credo che gli Amici di Brera possano contribuire a diffondere maggiormente tra soci e cittadini interessati una conoscenza approfondita degli strumenti effettivamente a disposizione per la soluzione dei problemi complessi e numerosi di Brera e di altre istituti e luoghi della cultura; soluzioni, che non sono facili da individuare e perseguire e che, peraltro, possono essere diverse e parimenti legittime, a seconda degli obiettivi veri che si intenda perseguire; obiettivi che in verità il Governo, nel caso di Brera, non ha ancora reso noti, a parte il genericissimo riferimento al «miglioramento della valorizzazione dell’Istituto, nonché alla gestione secondo criteri di efficienza economica»: finalità che qualunque forma di gestione, pubblica o privata, non potrebbe certo ignorare.
Le soluzioni individuate per Brera alcuni anni or sono dal Governo nazionale, con tanto di accordi sottoscritti (l’ultima volta, se non erro, il 20 luglio 2010) da tutti gli enti in causa, come Ella ha più volte ricordato, non sono state purtroppo perseguite fino in fondo o forse, a un certo punto, sono state giudicate non più adeguate. Certamente sono state poco spiegate alla gente e, ritengo, anche a quanti hanno incomprensibilmente visto un oltraggio all’Accademia di Belle Arti l’aver individuato per essa una sede aggiuntiva importante e potenzialmente funzionale. Ne' mi sembra che i commissariamenti statali abbiano sortito alcun effetto, come sempre accade quando si cercano scorciatoie a problemi realmente molto complessi e per i quali necessita diffusa comprensione e, se possibile, forte condivisione. Confesso che di tutto questo percorso non conosco alcun rendiconto pubblico puntuale, a parte quanto da Lei comunicato di tanto in tanto. Da vecchio appassionato delle sorti di Brera ho così deciso di rivolgermi proprio a Lei, che presiede l'unico soggetto oggi potenzialmente capace di tenere in costante raccordo il patrimonio e la memoria delle storiche istituzioni del Palazzo con gli «amici» di Brera e i cittadini in genere.
Senza dunque preoccuparmi di essere prolisso e di non essere un giurista (ma soltanto uno storico dell’arte con esperienza diretta di gestione di beni e servizi culturali), desidero offrirle qualche personale riflessione, con lo scopo non tanto di schierarmi frettolosamente a favore o contro la decisione di costituire la fondazione, quanto di offrire, da amico agli «Amici di Brera», alcune piste di riflessione che vogliono tenere in conto soprattutto la Costituzione ed il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, in quanto fondamenti ineludibili della nozione di «valorizzazione» del patrimonio culturale, finora rimasta estranea al dibattito, attento esclusivamente ai temi della gestione economica e della fruizione pubblica del museo; mentre la legge 134/2012 individua proprio nel «miglioramento della valorizzazione dell’Istituto» la prima delle finalità che si intende perseguire.
Comincerò un po' da lontano.
Il dibattito che oggi riguarda in particolare la Pinacoteca nazionale di Brera non ha introdotto, al momento, contenuti innovativi. Forse gli spunti più interessanti risalgono agli scritti di Franco Russoli, alla metà degli anni Settanta del secolo scorso, quando il contesto culturale, sociale, economico e giuridico del Paese era peraltro molto diverso dall’attuale. Oggi a lui è dedicata una strada alla periferia di Milano.
Il dibattito si riproduce infatti da decenni sul solito fondale: il rapporto tra «pubblico» e «privato»; questione vista ormai da tempo secondo abusati cliché, che, a seconda degli intervenuti, vedono volta a volta la gestione pubblica diretta come unica possibile garanzia del pubblico interesse per la tutela, ovvero come causa di ogni inefficienza economica e gestionale; e vedono all’opposto nella gestione privata l’unica speranza di efficienza (intesa come sostenibilità economica e garanzia di pubblico accesso continuativo ai beni culturali), ovvero la più spregevole mercificazione di un patrimonio, che merita invece di essere salvato a spese della collettività e non svenduto agli speculatori privati (ma non dimentichiamo che molte speculazioni sul patrimonio culturale sono opera di soggetti pubblici).
Non v’è dubbio che queste odierne dicotomie di approccio abbiano remota origine nella statizzazione della responsabilità e del potere di identificare e gestire il patrimonio culturale, così come andò definendosi soprattutto negli anni dell’epopea napoleonica e, poco dopo, con l’Editto Pacca promulgato nello Stato Pontificio. Un processo che, da allora, si è espanso progressivamente in diversi stati d’Europa con leggi nazionali «di tutela», che hanno avuto l’enorme merito, grazie ad un potere statale centralizzato, di sottrarre alla dispersione ed alla dilapidazione una parte significativa del patrimonio culturale privato ed ecclesiastico, tenendolo il più possibile legato ai contesti d’origine; come, in fondo, già i consulenti di Papa Urbano VIII gli avevano permesso di disporre con la significativa e celebre normativa sul «fidecommisso».
Alla base dell’opposizione manifestata dalla lettera aperta contro la decisione governativa di costituire la fondazione «La Grande Brera», della quale condivido diversi contenuti, rilevo soprattutto la convinzione che l'interesse pubblico possa venire assicurato esclusivamente da una gestione in capo ad un soggetto pubblico, mentre è considerato «privatizzazione» «il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell’immobile che la ospita, nonché degli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale». In realtà fin dalla sua promulgazione la nostra Costituzione, più di altre carte fondamentali europee, sostiene il principio che non solo gli enti pubblici, ma anche chiunque abbia cittadinanza debba concorrere allo sviluppo sociale, economico e culturale della nazione (art. 4). Che è peraltro idea non così lontana da quel principio di sussidiarietà, che, nato nella Chiesa Cattolica, trasmigrato negli ordinamenti europei e nel 2001 affermato dalla riforma costituzionale in Italia, vi attende ancora concreta e piena attuazione. Di qui alla privatizzazione c’è evidentemente una bella differenza; almeno altrettanta quanto ce n’è fra il decentramento invocato da Andrea Emiliani quaranta anni fa e certe istanze secessioniste di oggi. Ma può davvero equipararsi quanto disposto dalla legge 134/2012 ad un processo di privatizzazione?
Il problema di fondo - in qualche modo evocato dagli interventi di Asproni, Bertelli e Resca, riportati dal Corriere della Sera dopo Ferragosto - può articolarsi in un paio di domande, che cercherò di formulare con diretto riferimento al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
1) Se, come il Codice giustamente dispone (art. 2, comma 4), i beni culturali di appartenenza pubblica sono destinati alla pubblica fruizione e pertanto devono essere, per dir così, l'avanguardia di tutti i progetti di valorizzazione (cfr. artt. 6 e 111), quale è in concreto il progetto organico di valorizzazione per il quale abbia senso per Brera scegliere la forma giuridica della fondazione di diritto privato invece di altra soluzione, ad esempio quella di costituire un polo Museale con il Cenacolo Vinciano oppure un ente che abbia forma consortile pubblica, come peraltro auspicato dal Codice dei Beni culturali (art. 115, c. 2)? La politica ha il diritto-dovere di scegliere, ma il Codice, oltre che la buona prassi di amministrazione, impone comunque di motivare le scelte (Codice, art. 115, c. 4, secondo periodo).
2) Per quali buoni e convincenti motivi i «privati» (sempre così genericamente definiti) dovrebbero coinvolgersi in tale progetto di valorizzazione contribuendo «ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto»? E quali modalità concrete di coinvolgimento per essi si auspicano? Con quali garanzie di sostenibilità nel tempo? Con quali sistemi di indirizzo, rendicontazione, controllo - a parte la Corte dei Conti, alla quale non spetta ovviamente il controllo sugli aspetti museologici e tecnico-scientifici?
Di fatto, molti fautori e altrettanti detrattori dell’intervento privato per la gestione dei beni culturali pubblici sembrano parimenti convinti che la salvaguardia del patrimonio culturale si realizzi con due soli strumenti: il potere autorizzatorio (da sempre saldamente in mano pubblica), per assicurare la tutela, ed i soldi per fare le cose. Partendo da questo assunto, visto che ai «privati» non si può certo assegnare la responsabilità della tutela, a loro si chiedono soldi da erogare come mecenati o come sponsor, per assicurarsi visibilità associandosi al prestigio del patrimonio culturale; oppure si sollecita (come nel caso della legge 134/2012) la partecipazione privata alla governance dell’ente di gestione, a fronte, evidentemente, di un’adeguata contropartita finanziaria; oppure si propone ai privati un impegno imprenditoriale, ad esempio un intervento in project financing per gestire beni culturali.
Devo dire che trovo davvero riduttivo immaginare che il rapporto fra patrimonio culturale e società si riduca al rapporto pubblico-privato; e trovo avvilente invocare l’apporto privato soltanto come elargizione generosa in supplenza di fondi pubblici che non ci sono. La richiesta ha il tono davvero preoccupante della resa dei pubblici poteri di governo al potere insostituibile di chiunque abbia soldi; dà l’idea di uno Stato che impone una tassazione elevatissima a chiunque non possa evadere il fisco, ma nega a se stesso i fondi per i suoi propri beni culturali. Quale privato potrà realmente coinvolgersi a lungo termine in un simile programma di gestione della cosa pubblica e in particolare del patrimonio archeologico, artistico e storico, desiderando di esserne partner, o addirittura mecenate della sua gestione?
In verità, come tutte le più accreditate ricerche sul tema dimostrano, con un approccio povero di «visione» strategica e di progettualità concreta, non vi sarà prospettiva neppure per lo sviluppo di maggiori competenze manageriali in ambito pubblico: in fondo, se tutto si riduce ad una questione di soldi, bastano le ordinarie competenze burocratico-amministrative per gestire senza rischiare imputazioni per danno all’erario. Nel contesto macroeconomico la riduzione dei problemi di tutela e valorizzazione dei musei alla mera attività di fund raising riduce l’attrattiva del bene culturale pubblico alle prospettive di redditività della sua gestione, proprio perché l'unica sfida che si ritiene di affrontare sembra essere quella di trovare soldi privati per coprire i buchi del bilancio pubblico; con il sottinteso che, se i soldi pubblici fossero sufficienti, forse nessun coinvolgimento di risorse aggiuntive private verrebbe auspicato e sollecitato dai pubblici poteri di tutela.
A questo punto, ritiratisi ovviamente in buon ordine sponsor e mecenati - poco affascinati, suppongo, da una simile prospettiva - possono restare in campo gli imprenditori interessati al settore culturale: ma se ad essi non si chieda una semplice fornitura di beni e servizi a fronte di un compenso contrattualizzato, bensì un impegno di partecipazione a costi e ricavi nel lungo periodo, dunque la condivisione del rischio d’impresa, è difficile ottenerne il partenariato senza un accordo sulla progettazione strategica della valorizzazione del patrimonio culturale. E se tale progettazione non vi fosse, chi fa l’imprenditore chiederebbe delega a svilupparla in proprio, per dare un senso all’assunzione del suo rischio.
E qui viene fuori il vero problema: la valorizzazione del patrimonio culturale, come definita dal Codice (artt. 6 e 111), non è in primis un servizio da appaltare - neppure in project financing - ma è una vera e propria irrinunciabile funzione di governo! Così infatti stabilisce la Costituzione dal 2001, affidando alle Regioni il compito di regolamentarla con proprie leggi, sia pure nel rispetto di principi generali nazionali, che lo Stato ha promulgato fin dal 2004 nel corpo stesso del Codice.
Cosa manca allora? Mancano norme tecniche e linee guida che, secondo il Codice, spetta al Ministero adottare in collaborazione con le Regioni, sia sul fronte della tutela che su quello della valorizzazione (si vedano, per esempio, gli artt. 17 c. 2; 29 c. 5; 112 comma 4, 114, etc.), per creare quel contesto di regole chiare che dia ai soggetti coinvolgibili, pubblici o privati che siano, certezza di trasparenza e riferimenti necessari per dare una qualche misura al rischio imprenditoriale.
Si tratta componenti essenziali del sistema, perché dovrebbero sottrarre i progetti operativi di valorizzazione (ad iniziativa pubblica o privata) e i connessi piani economici di gestione alla casualità di decisioni troppo discrezionali nei modi e nei tempi. Si tratta, insomma, della definizione del «come si fa» concretamente quello che Costituzione e Codice prescrivono in astratto. In assenza di puntuali e realistiche norme tecniche e linee guida - che promuovano reale competitività assicurando spazi certi di manovra alla creatività dei curatori museali e degli imprenditori culturali - diviene difficile tenere in equilibrio esigenze della tutela ed esigenze della gestione e della fruizione pubblica con le esigenze della sostenibilità economica; e dunque risulta più che legittimo sollevare dubbi sulla corretta gestione dei beni culturali da chiunque esercitata, si tratti di ente pubblico o di ente di diritto privato; con o senza fondazione.
Le Regioni tuttavia non hanno ancora raccolto seriamente la sfida - ad esse affidata dalla Costituzione - di normare la valorizzazione del patrimonio culturale dei beni non statali come funzione propria del governo territoriale; anzi, soprattutto dal 2005, sembrano complessivamente aver abbassato l'attenzione per il governo del patrimonio culturale, che negli anni immediatamente precedenti avevano invece espresso con efficacia, sia durante la formazione dell'atto di indirizzo statale sulla gestione dei musei (2001, poi purtroppo abrogato dal Codice all’art. 184), sia nella fase di produzione del Codice stesso (2004). D’altra parte, come poi dirò con maggior dettaglio, un programma di valorizzazione di un importante museo statale che ignori le sinergie possibili con altri istituti culturali non statali, pubblici o privati, sarebbe oggi del tutto fuori dalla realtà.
Capisco che molti vedano con sospetto la funzione di valorizzazione riferita ai beni culturali, soprattutto da quando le norme sulla cartolarizzazione volute dall’allora ministro Tremonti utilizzarono la parola come sinonimo di dismissione e monetizzazione di immobili pubblici; e questi sospetti sarebbero sacrosanti, se il legislatore non avesse introdotto nel Codice l’art. 12 e non avesse precisato la finalità della valorizzazione nel «promuovere lo sviluppo della cultura» (art. 6, c. 1). D’altra parte, a chi voglia seriamente prenderlo in esame, il Codice chiarisce a sufficienza che la tutela dei beni culturali pubblici non si giustifica in se stessa, ma ha come fine precipuo la loro valorizzazione e fruizione pubblica (art. 2 c. 4 e art. 6). E non dice affatto che questo fine debba essere perseguito esclusivamente ad opera di soggetti pubblici; anzi, riconosce che la valorizzazione di beni culturali pubblici ad iniziativa privata «è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (art. 111, c. 4), ossia andrebbe premiata con benefici fiscali. Peccato che ne' governi ne' parlamenti ne tengano conto!
Insomma, le Regioni e, in parte, lo Stato hanno sostanzialmente interrotto nel 2005 la loro cooperazione di legislatori della valorizzazione, lasciando in sospeso la riflessione e le decisioni sugli aspetti tecnici ed organizzativi che ne riguardano l’esercizio, fra esigenze della tutela ed esigenze di un godimento pubblico economicamente ed organizzativamente sostenibile; di conseguenza, non si dispone al momento di quelle linee guida semplici e certe in base alle quali l'apporto di privati alla valorizzazione (ad esempio partecipando ad una fondazione o a una società, o in altro modo) possa svilupparsi con chiari riferimenti tecnici, procedurali, economici, evitando percorsi incerti nei tempi di autorizzazione, di cofinanziamento, di realizzazione. Per esempio, si pensi alla pesantezza ed alla confusione delle procedure relative alle riproduzioni fotografiche e cineaudiovisuali di beni culturali statali - così importanti per le attività editoriali e di promozione - lasciate ormai sostanzialmente alla discrezionalità e mutevolezza delle singole Soprintendenze, se non dei singoli funzionari, ma comunque con procedure difficilmente comprensibili, quando addirittura inconoscibili; ma è solo un
esempio.
In sostanza, con un accordo Stato-Regioni, andrebbe definito in modo semplice e chiaro:
a) come assicurare il rispetto delle esigenze della tutela (art. 6, comma 2) in tempi e modi non vessatori per chi assuma la gestione di beni culturali pubblici (art. 6, comma 3) ma comunque efficaci per la migliore conservazione possibile ed il godimento pubblico dei beni culturali nel mediolungo periodo (artt. 111 e 114);
b) quali precisamente debbano essere i contenuti ineludibili dei contratti di servizio previsti
all'art. 115 comma 5 del Codice, visto che sulla base di essi si dovrebbe assicurare il controllo sul rispetto degli impegni da parte dei concessionari d’uso di beni culturali (ad es.: la costituenda fondazione «La Grande Brera»); al punto che, sempre secondo il Codice, il mancato rispetto di tali impegni autorizza sostanzialmente l’amministrazione concedente a rescindere unilateralmente il contratto di concessione senza alcun indennizzo per il soggetto concessionario (art. 115, c. 6, secondo periodo);
c) con quali criteri e strumenti integrare ciascun progetto di valorizzazione con le opportunità
offerte dal contesto territoriale ed in particolare con «le infrastrutture ed i settori produttivi collegati» che lo caratterizzano (cfr. art. 112 c. 4) oltre che, ovviamente, con altri asset culturali viciniori e
possibili partner.
In altre parole, il soggetto pubblico possessore (come proprietario o consegnatario) di beni culturali, che accetti di valorizzarli direttamente (ad esempio con la forma consortile pubblica, art. 115 c.2), o che accetti una proposta privata di valorizzazione (art. 111 c. 2), non può limitarsi a trattare il patrimonio culturale come un asset immobiliare dal quale ricavare più soldi possibile, perché il Codice Civile ed il Codice dei Beni culturali - per non parlare dell’art. 9 della Costituzione - attribuiscono al patrimonio culturale uno status diverso dagli altri asset immobiliari pubblici; ma deve seriamente dimostrare di considerarlo entità produttiva di valore nel contesto territoriale, sulla base di una progettualità dettagliata e molto concreta (dunque con un attendibile piano di partenariato ed un appropriato business plan), in coerenza con una visione che deve essere prioritariamente condivisa con quanti governano o rappresentano comunque legittimamente gli interessi pubblici del territorio.
Per gli stessi motivi, ai soggetti imprenditoriali che vogliano concorrere ad attuare un progetto di valorizzazione non si dovrebbe far credere che ciò sia possibile limitandosi a gestire l'accesso al bene ad essi conferito ed il suo sfruttamento immobiliare o editoriale; dovrebbero invece venire contrattualmente impegnati a produrre alleanze ed accordi commerciali e di promozione culturale estesi al territorio, capaci di incrementarne tutti i possibili apporti ed esternalità positivi.
La decisione su quale debba essere la natura giuridica ed organizzativa del soggetto chiamato a gestire e valorizzare un patrimonio tutelato deve, dunque, seguire (e mai precedere) la condivisione di un piano strategico di sviluppo culturale e valorizzazione di esso, sia per logica di buona amministrazione sia per ottemperanza alla specifica disposizione del Codice (art. 112 c. 4). Se invece il processo si capovolge, come purtroppo sta succedendo anche per Brera - in quanto la forma giuridica del soggetto gestore è stata decisa dalla legge 134/2012 prima che sia ben configurato (o conosciuto) il progetto culturale ed economico - o se gli accordi tra i componenti della governance restano generici, addirittura non vengono formalizzati e sanzionati, o se non si prevedono azioni periodiche di verifica, allora ogni sforzo e spesa presto risulteranno vani. Anche in un caso di indubbio successo come quello della Venaria Reale (gestita da un consorzio), la mancata corresponsione di contributi, che erano stati garantiti, alla lunga potrebbe creare gravi conseguenze sul bilancio dell'ente, mettendo a rischio l'ingente investimento compiuto e in particolare la continuità della conservazione del bene e della sua fruizione pubblica nel tempo. E qui va precisato che spesso è inutile l'immobilizzo di importanti somme nel fondo di dotazione delle fondazioni culturali, mentre sono decisive la certezza e l'entità del riprodursi ogni anno di adeguate risorse per il fondo di gestione (come, peraltro, opportunamente previsto per Brera dalla l. 134/2012); a meno che il fondo di dotazione non sia di tale entità, da poter produrre, con una rendita ben amministrata, almeno le risorse necessarie per la buona gestione.
Il problema dunque, nel caso di Brera come in tanti altri casi consimili, si articola in due livelli:
una carenza normativa, per la perdurante mancanza a livello nazionale e regionale dei regolamenti tecnici sulla gestione e sulle procedure di valorizzazione e tutela (ma per i musei si potrebbe almeno «richiamare in vita» immediatamente l’atto di indirizzo di cui al decreto ministeriale del 2001); e poi la mancanza di un chiaro progetto di valorizzazione, che integri gli aspetti museografici e museologici con quelli finanziari, organizzativi e promozionali, con le progettualità ed i servizi culturali del territorio, ma anche con gli aspetti sociali, imprenditoriali, infrastrutturali, come richiesto dal Codice.
Tale progetto strategico - lo ribadisco - deve formare oggetto di un accordo formale, ad es. un accordo di programma, tra ente fondatore ed enti promotori (come prevede il Codice, art. 112 c. 4), che preceda la definizione della forma giuridica della gestione e delle regole di governance, così come delle dotazioni finanziarie, aspetti tutti da considerarsi strumentali rispetto allo scopo e al progetto da perseguirsi.
Con un percorso così articolato si potrebbe superare, anche nel caso della Pinacoteca di Brera, il rischio di una perdurante estraneità del suo straordinario patrimonio culturale (soprattutto se raccordato alle dotazioni archivistiche, librarie e storico-artistiche dell’Accademia di Belle Arti e della Biblioteca nazionale Braidense) rispetto al governo sociale ed economico dello sviluppo della Lombardia, a partire da Milano, se si vuole che patrimonio culturale e ricerca non vengano mercificati ovvero consegnati al buon cuore di elemosinieri, ma siano invece componente attiva di tale sviluppo. Mi permetto di dire che dirigenti, docenti, funzionari dei diversi Istituti braidensi dovrebbero ricevere come obiettivo correlato alla loro retribuzione di risultato concreti impegni di cooperazione in questa direzione, sulla base di una progettualità condivisa.
Tutto questo implica, soprattutto nel caso di Brera, la necessità di non delegare o rinviare il progetto di valorizzazione, comunque di non rinunciarvi, costruendolo in modo cooperativo con il territorio. Implica insomma la necessità di un lavoro comune fra Ministeri cointeressati ed altri stakeholder pubblici e no-profit (ad es. Regione Lombardia, Comune di Milano, università, associazioni, fondazioni di origine bancaria) per metterlo a punto avvalendosi di ogni utile contribuzione.
Consultarsi fra enti pubblici e soggetti privati soltanto per mettere insieme una dote economica di start up per Brera sarebbe apparentemente apprezzabile, ma in realtà ingannevole. I soldi evidentemente ci vogliono, ma per non sprecarli occorre, prima ancora di chiederli e raccoglierli, chiarire cosa se ne vuol fare, non soltanto nella fase di investimento ma anche in quella di gestione a lungo termine. Su un forte progetto, sarebbe più facile selezionare sponsor e partner privati disposti ad un impegno continuativo.
Definito tutto questo e costituito fra enti pubblici e con forma giuridica appropriata il soggetto gestore, esso, se necessario, può indire con opportuna sequenza le procedure di evidenza pubblica necessarie a reperire risorse e partner dal mercato e dagli stakeholder del territorio e magari anche dall’estero. Il Governo del resto ha annunciato di voler emanare un regolamento sulle sponsorizzazioni per il patrimonio culturale (cfr. il Codice, art. 120). E’ ragionevole comunque ritenere che le fondazioni costituite per legge (tanto più se assoggettate esplicitamente al controllo della Corte dei Conti, come previsto dalla l. 134/2012) abbiano carattere sostanzialmente pubblico e che, pertanto, l’individuazione di privati come partecipanti sia da definirsi con procedure di evidenza pubblica (cfr. Codice, art. 115, c. 3) e perciò a condizioni trasparenti e a tutti note. Né va ignorato che i privati (ad es.: imprese), che siano membri di una fondazione o di altro soggetto di valorizzazione, non possono poi esserne anche concessionari di interventi di valorizzazione (art. 115, c. 3, secondo periodo).
Ma poiché occorre perfezionare al meglio una così complessa progettualità anche in fase di gara - evitando per quanto possibile esiti imprevisti e insoddisfacenti, ancorché vincolanti - si potrebbe fare ricorso alla procedura cosiddetta del "dialogo competitivo", introdotto nella normativa europea dalla Direttiva 2004/18/EC e recepita in Italia con il Codice degli appalti (d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Si tratta di una procedura, purtroppo poco o per nulla adottata in Italia nel campo degli investimenti per la la valorizzazione dei beni culturali, che, sulla base di obiettivi sufficientemente dettagliati ad opera della committenza (acquirente), consentirebbe di acquisire con assoluta trasparenza, in fase di pre-gara, le migliori ipotesi di soluzione che il mercato (l'insieme dei più validi fornitori potenziali, selezionati dalla stazione appaltante) possa offrire, riservando comunque alla stazione appaltante la facoltà di recepire o meno le proposte così raccolte negli effettivi documenti della gara pubblica, che avrebbe luogo dopo il dialogo competitivo.
Il metodo dell’accordo di programma per la costruzione del piano di valorizzazione e del "dialogo competitivo", per l’arricchimento del progetto stesso nella fase di individuazione di partner o fornitori privati in sede di gara pubblica, potrebbe dare trasparenza e concretezza ad una relazione, quella pubblico-privato, che non può essere sottratta, nell’attuale ordinamento italiano ed europeo, alla normativa sulla concorrenza, anche se si tratta di gestire beni culturali. D'altra parte, per migliorare la gestione dei servizi indispensabili, rendendoli meno costosi e più efficaci, occorrerà puntare sempre più sull'integrazione e, dunque, sulla ottimale gestione delle complessità. Sarà dunque ancor più giustificato il ricorso al "dialogo competitivo", non soltanto per migliorare le soluzioni nel rapporto con il territorio (ad es. per definirne la dimensione ottimale di riferimento), ma anche per la gestione tecnica del singolo museo.
Per fare un esempio, basti pensare a quanto sarebbe importante per complessi museali di una certa dimensione disporre di protocolli tecnici e servizi di "facility management integrato", capaci cioè di tenere sotto stretto controllo in modo integrato attività che solitamente rimangono estranee e scoordinate l'una rispetto all'altra, con produzione di costi inutili e disservizi, talvolta gravemente dannosi per la conservazione stessa del patrimonio culturale: misure di sicurezza attive e passive; gestione energetica; pulizie; processi di monitoraggio e di manutenzione programmata del contenitore e dei beni custoditi; accoglienza e servizi al pubblico. Si tratta in ogni caso di servizi davvero delicati, complessi ed essenziali per un museo, ma soprattutto di funzioni fra loro tutte interdipendenti negli effetti sul patrimonio e sul pubblico: si pensi, ad esempio, allo stretto e talvolta conflittuale rapporto fra i parametri di climatizzazione graditi al pubblico o ai lavoratori e quelli appropriati per i beni culturali da proteggere; e altrettanto potrebbe dirsi sui sistemi di illuminazione, i servizi di sorveglianza o i sistemi di sicurezza. Altro che limitarsi a parlare di "servizi aggiuntivi", come venne di moda vent'anni fa con la legge Ronchey, quando si pensava che bastasse un bookshop, un bar ed un guardaroba per rendere "moderno" e funzionale un museo!
Purtroppo le gare sui "servizi aggiuntivi" - nate e cresciute nell'ossessione della mancanza di fondi nelle casse pubbliche - si svolgono da decenni prendendo a tema non un progetto integrato di valorizzazione in «ambiti territoriali definiti», come vorrebbe il Codice (art. 112, c. 4), ma una mera attività di concessione in gestione di alcuni servizi ritenuti a torto collaterali, separabili, dal "core" dell'attività museale, ancorché produttivi di reddito. L'approccio rischia di essere soltanto amministrativo, non culturale né economico o sociale. L'analisi economica dei bisogni sociali di crescita culturale, l'interazione con il territorio, l'apporto dell'innovazione organizzativa e tecnologica, l’educazione, la socializzazione delle conoscenze, rischiano spesso, nonostante le dichiarazioni, di restare fuori dai bandi di gara sui servizi aggiuntivi, orientati invece a monetizzare al massimo, a vantaggio dello Stato, la fruizione del patrimonio culturale.
Che peccato, quante occasioni perdute! Non è questa una sorta di mercificazione di Stato?
Senza un progetto integrato (che richiede di uscire dalle anguste competenze statali, per allargarsi ad un partenariato ampio) non si riesce a radunare le idee e le risorse migliori e a metterle in opera con adeguate sinergie. Proprio per questo la Costituzione riconosce saggiamente che la valorizzazione del patrimonio culturale è materia la cui legislazione non sia esclusivamente statale o regionale, ma "concorrente", cioè di competenza regionale purché coerente con principi generali fissati per tutto il territorio nazionale da norme statali. Ed è per la medesima ragione che i risultati migliori possono ottenersi su scala territoriale con accordi di programma formalizzati come veri e propri contratti (dunque con apporti finanziari precisamente programmati, procedure rigorose di monitoraggio nel tempo, sanzioni) e non si arrestino a generiche espressioni di volontà. La legge prevede che essi vengano stipulati fra soggetti pubblici e che vi possano aderire anche privati che motivino il proprio interesse.
Si consideri poi l'importante evoluzione maturata di recente, soprattutto in Lombardia, nel mondo dei professionisti dei servizi culturali, che, adottando un approccio mirante proprio all'integrazione delle competenze e dei servizi, dunque alla razionalizzazione delle risorse, hanno costituito l'associazione MAB, il cui nome risulta dall'acronimo di "musei archivi biblioteche"; quale luogo della cultura più del Palazzo di Brera può essere preso a caso di studio appropriato?
Proviamo allora, partendo magari proprio da Brera, a cambiare ottica.
Riassumendo. Dobbiamo superare l’errata convinzione (statale o privata che sia) che l'obiettivo prioritario sia quello di "far cassa", solo perché mancano le risorse pubbliche. Acquisire le risorse finanziarie necessarie è banalmente essenziale per qualunque progetto; ma per attrarre partner e risorse occorre una “visione” strategica convincente ed attrattiva, un progetto chiaro che sia riconoscibile dai cittadini e dagli sponsor come attrattivo, coerente con i propri obiettivi e valori etici; ed è poi ovvio che una componente essenziale dell’attrattività dei progetti di valorizzazione è la dimostrazione della sostenibilità culturale ed economica nel medio-lungo termine. E questo obiettivo, se non si immagina una spesa pubblica senza limiti, richiede forte condivisione con gli enti e la popolazione cointeressati, dunque comporta precise analisi per il raccordo con l'insieme delle energie sociali, culturali ed economiche del bacino di fruizione dei beni.
Spero proprio, egregio Presidente Bassetti, che gli Amici di Brera possano essere promotori di una migliore comprensione da parte dei cittadini di quanto essi stessi per primi possono pretendere
dalle Istituzioni. In base alla Costituzione e nel rispetto delle leggi.
Suo
Pietro Petraroia