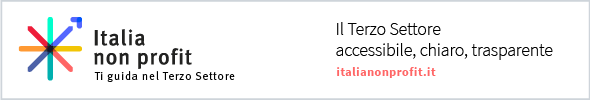Diamo i numeri (continua)
Non esiste un censimento dei beni culturali del mondo e quindi non esistono dati certi da attribuire ad un paese, ma possiamo affermare che il patrimonio culturale dell’Italia è straordinario, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, con caratteristiche uniche: il maggior numero di beni culturali riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità (ben 51, il 5% del totale) e testimonianze storiche degli ultimi millenni, senza soluzione di continuità. Non c’è paese al mondo che abbia queste caratteristiche. I dati rendono evidente la responsabilità che grava su tutti noi e, allo stesso tempo, le potenzialità in parte inespresse. Il patrimonio, diffuso capillarmente, è contrassegnato da grandi “attrattori” e da “beni minori”, elementi costitutivi e identitari delle comunità e luoghi di interesse per milioni di visitatori stranieri. I protagonisti sono tanti. Basti pensare a quanti e diversi sono i proprietari di musei o di palazzi, chiese, castelli e così via. Tutto questo ha generato un modello di gestione prevalentemente statale che si è costruito nel tempo e, soprattutto, negli ultimi cento anni. Non è questa la sede per valutarlo ma possiamo affermare che è opinione prevalente che debba essere sottoposto ad un “tagliando”, complice la situazione del debito pubblico, la crisi economica, la scarsità delle risorse. Ne è riprova il fatto che in questi ultimi anni la dimensione quantitativa del patrimonio ha sollecitato studiosi e politici a dare ad esso un valore economico, altri a proporne la dismissione, altri ancora ad affidarlo ai privati. Nessuna di queste ipotesi ha preso forma nelle politiche pubbliche. E tuttavia resta forte l’esigenza di affrontare il tema per non doversi trovare di fronte a scelte drastiche come è avvenuto nel campo sanitario o in quello pensionistico. Il dibattito è aperto. Per ora si assiste ad un confronto (con vis polemica..) fra chi sostiene che il patrimonio va difeso “sempre e comunque” (ma in realtà si difende il modello di gestione imperniato sul sistema pubblico e sulle soprintendenze) e chi propugna un sistema più aperto, orientato al business, con un ridimensionamento della presenza pubblica. E’ la posizione di chi vorrebbe applicare le regole del libero mercato. Entrambe le posizioni non offrono una soluzione. Se la prima non tiene sufficientemente conto delle rigidità della spesa pubblica determinata dalla dimensione del debito, la seconda sottovaluta il carattere pubblico, proprio delle politiche culturali, e immagina un ruolo per i privati che, nella forma auspicata, non ha preso forma nemmeno nei paesi anglosassoni.
Tuttavia resta l’esigenza del “tagliando”. Vediamo perché e, soprattutto, se c’è spazio per una proposta non ideologica. Prendiamo qualche numero dal Rapporto ISTAT sui musei. L’Italia ha circa 4 mila musei, di cui oltre 200 statali (su 420 istituti). Il resto è prevalentemente di proprietà comunale (ma ci sono molti musei privati ed ecclesiastici). Oltre 2.000 aree archeologiche. Più di 100 milioni di visitatori di musei, aree archeologiche e monumenti, di cui meno della metà paganti. Il 33% dei musei incassa meno di 20.000 euro l’anno. Circa il 64% è visitato da meno di 20.000 persone l’anno e solo il 3,6% supera i 100.000 visitatori. Fino a qui i dati quantitativi. Ma ci sono altri elementi. Il 21% degli spazi sono chiusi. Il 57% espone meno della metà delle collezioni. Il 50% non ha un sito web e l’84% non gestisce i canali social. Infine il 90% non dispone di connettività WI-FI gratuita e il 60% non ha personale che parla inglese. Criticità evidenti. Se guardiamo a questi dati con gli occhi di coloro che sostengono le posizioni che abbiamo richiamato, i primi addosserebbero tutte le responsabilità a Stato e Comuni che hanno decimato i finanziamenti alla cultura e bloccato le assunzioni, i secondi chiederebbero di “tagliare i rami secchi” e di privatizzare i musei per renderli finalmente produttivi. Va da sé che non ci aiutano a trovare una soluzione per affrontare le molteplici criticità.
Cerchiamo di sondare altre strade. E’ necessaria una premessa. Poiché qualunque politica ha bisogno di visione, di risorse conseguenti, di strutture adeguate, di verifiche e controlli, è necessario accertare se il sistema pubblico ha maturato la convinzione che conoscenza, cultura rappresentano ingredienti fondamentali di una politica di sviluppo economico e sociale del Paese e si comporta di conseguenza. Se stiamo alla più recente produzione legislativa (soprattutto la cosiddetta legge Art bonus) e alla inversione di tendenza rispetto alle risorse destinate alla cultura, dovremmo concludere che ci sono segnali incoraggianti. Si può quindi mettere mano al “modello”, auspicando uno sguardo lungo, con uno Stato che si fa accompagnatore dei processi, cercando e valorizzando le migliori esperienze che ci sono nel Paese, favorendo l’apporto delle Amministrazioni locali, stimolando la partecipazione dei cittadini e rendendoli partecipi della cura e della valorizzazione del proprio patrimonio culturale.
Qualche esempio per stare sul concreto. La gestione dei musei ha un costo rilevante. Si possono sicuramente contenere i costi e incrementare i ricavi. Dal lato dei ricavi si può promuovere una politica per incrementare il pubblico pagante (ci sono ancora troppe agevolazioni ingiustificate), migliorare la comunicazione, l’uso dei social, l’accoglienza e l’accessibilità per allargare la domanda, una politica culturale internazionale più coraggiosa (vedi l’esperienza del Louvre ad Abu Dhabi che ha generato 525 milioni di euro per l’uso del marchio e 720 milioni per l’affitto delle opere). Dal lato dei costi c’è un problema di efficientamento energetico, di utilizzo delle tecnologie per migliorare la sicurezza, di una lotta agli sprechi. Sempre sulla gestione, si può fare un esempio con riferimento ai musei meno visitati e alle realtà più piccole. La soluzione non è chiudere o continuare a tenerli aperti, comunque. Accompagnare i processi vuol dire, ad esempio, che, regione per regione, lo Stato apre un confronto con le istituzioni locali per adottare soluzioni condivise. C’è un fiorire di iniziative locali dove organizzazioni no profit, cooperative, volontari già si occupano di beni abbandonati. Sono animate prevalentemente da giovani laureati, appassionati del loro lavoro, che hanno trasformato questi spazi in luoghi vivi, di interesse per le proprie comunità e non solo. Da luoghi spesso abbandonati o poco valorizzati, si sono trasformati in centri di innovazione culturale e sociale, generando nuove esperienze e opportunità lavorative. Ecco cosa vuol dire mettersi in relazione con le comunità locali: utilizzare, valorizzare risorse ed esperienze locali per cercare soluzioni adatte al singolo caso. Siamo quindi lontani dalla logica di provvedimenti calati dall’alto, che hanno la pretesa di indicare soluzioni buone dalla Valle d’Aosta alla Calabria (la Sicilia fa da sola..). Ma siamo anche distanti da gelosie istituzionali che impediscono spesso una leale collaborazione fra le istituzioni e un uso razionale delle scarse risorse disponibili. Bisogna riscrivere le regole e ridisegnare l’organizzazione dell’offerta culturale del Paese. Il tempo che stiamo attraversando richiede coraggio, innovazione, capacità di affrontare le sfide del futuro guardando al bene comune e meno ai propri piccoli interessi. Ce la possiamo fare.
Ledo Prato è Segretario generale Mecenate 90