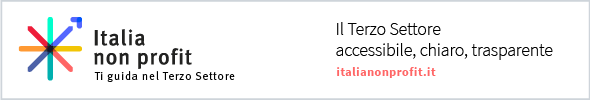Non ci sono paesaggi com’erano e dov’erano
Continua l’emozione e non riusciamo a elaborare il sisma con calma, mentre il progetto per riabitare i paesi distrutti richiede lucidità e disincanto, per trovare la via tra l’alienazione delle new towns e l’utopia irrealizzabile della ricostruzione perfetta
Per qualche malia antichissima la nostra memoria collettiva è piena di rimozioni di eventi gravi, che, come Sigmund insegna, non ricordiamo ma continuano a farci male, ancor più quanto più ci ostiniamo a negarli. Così uno dei peggiori disastri degli scorsi decenni, il DOPO terremoto de L’Aquila, di cui oggi pochissimo si ragiona, genera reazioni comprensibilmente assolutistiche, ma nefaste, nelle dichiarazioni affannate delle autorità coinvolte nei nuovi sismi: “ rifaremo tutto com’era e dov’era” (sottinteso: “non come a L’Aquila”). Già da mesi un coro di tecnici e intellettuali rammenta la necessità di una revisione tecnico scientifica del concetto di conservazione, che ci faccia uscire dalla falsa alternativa tra prefabbricato e soprintendenza (ad esempio il bell’articolo di Elena Granata sul blog di recuperoeconservazione del 7 settembre scorso).
Partiamo dalle conclusioni di quella fase: i nuovi insediamenti sono mortali per il senso di comunità di quelli che provano a riabitare i luoghi disastrati, ma anche il rifacimento fotocopia dei vecchi borghi, fattibile solo con tempi lunghi (oltre 10 anni), costi alti e effetti stranianti (Granata parla di parodia delle facciate rifatte com’erano con dietro case nuove), non è efficace per restituire vigore alle comunità colpite. Occorre convincere i gestori e i tecnici del dopoterremoto ad adottare criteri diversi: più rapidi, efficaci per le comunità, duraturi, meno costosi e quindi ripetibili. Ma le indicazioni sinora avanzate non coprono l’insieme dei requisiti, anzi appaiono contradditorie, favorendo l’uno a discapito dell’altro. Certo si deve pensare all’utilizzo sistematico di materiali più elastici, come il legno o il metallo, ma non controlliamo tutto quello che ne consegue per l’aspetto degli edifici; certo occorre localizzarsi in modo più sicuro (ammesso che si riesca a stabilirlo), ma non sappiamo tutto quello che ne consegue per la memoria dei luoghi….
Una rotta per uscire dall’impasse può essere tracciata ricorrendo agli esiti metodologici del dibattito sui progetti di paesaggio. Da qualche anno si è consolidata l’idea che il paesaggio sia una realtà olistica, cioè percepita in modo unitario e integrato, in parte materiale ma in larga parte immateriale, legata alla percezione e alla memoria che del proprio territorio ha la comunità (di chi lo abita o lo visita). E’ una realtà in continua trasformazione, mossa da due motori: quello delle modificazioni fisiche del territorio e quello delle nuove e diverse modalità dello sguardo e della memoria degli abitanti, che procedono incessantemente, influenzate dalle dinamiche culturali generali e dalle variazioni di composizione della comunità. In genere i processi trasformativi sono lentissimi, soprattutto quelli culturali: ci accorgiamo che il paesaggio è cambiato solo quando rimaniamo assenti per molto tempo e conserviamo un’immagine stereotipata e immobile dei luoghi (e delle persone) che conosciamo, evidenziando al confronto la “violenza” delle novità.
Progettare miglioramenti del paesaggio con questi riferimenti significa inserire le modificazioni in progetto entro il quadro più generale e complessivo dei luoghi e del senso loro attribuito dalla comunità abitante, e misurare la qualità del progetto in base all’apprezzamento complessivo dei luoghi dopo gli interventi. Questo comporta una consapevolezza del progettista del corpus di valori su cui sta intervenendo: sia i luoghi fisici, sia la considerazione che di essi ha la comunità.
Con questo criterio ogni progetto che influisca su luoghi comuni, quelli che costituiscono il paesaggio identitario della comunità, è responsabile anche delle modifiche sul senso del paesaggio che induce sulla comunità.
Occorre che chi progetta conosca la struttura del paesaggio su cui agisce: le relazioni fondamentali che definiscono l’identità di un luogo, fisiche e nella memoria di chi ad esso è legato. Si tratta di capire il ruolo di quelli che Marco Romano chiama i temi collettivi: la chiesa, la piazza, la porta, il teatro,….punti cardinali dell’identità. Ma soprattutto vanno estratti gli aspetti di insieme che danno un senso definito a quel luogo. Sono pochi ma essenziali: certe dimensioni e caratteri dello spazio percepito, certi rapporti tra temi collettivi e tessuto ordinario del costruito, tra costruito e verde,….
Tutto il resto cambia continuamente, è cambiato negli ultimi secoli e cambierà nei prossimi.
In questi termini il disastro lasciato dal terremoto non è diverso da quello prodotto dagli sbreghi inconsapevoli delle periferie, dai capannoni allineati come TIR fuori porta, dalle banche che adornano nel dopoguerra le piazze della cattedrale: sono forze cieche e sorde che hanno alterato i luoghi ma soprattutto il loro ruolo nel senso del paesaggio locale della comunità.
Se i piani regolatori avessero avuto alla base questi ragionamenti ci saremmo potuti evitare i disastri del costruito. Ma vale anche per il distrutto: se si studiano i requisiti strutturali del senso del paesaggio condiviso di Norcia, o di Amatrice, si possono ottenere meno di 10 regole, da rispettare, lasciando per il resto libertà di sperimentazione su tutte le altre prestazioni (sicurezza, economia, velocità realizzativa, sostenibilità ambientale,….).
Saranno regole diverse luogo per luogo, da elaborare con la partecipazione degli esperti ma anche della comunità abitante. Devono essere il frutto di un processo di riappropriazione dei luoghi abbandonati, prima ancora sentimentale che materiale, che può avvenire in forma di evento, anche in tempi molto rapidi. Ad esempio una full immersion ben preparata che dura due week end, uno per seminare, l’altro per raccogliere le idee.
Così gli interventi per porre rimedio a questi disastri deriveranno da una consapevolezza del ruolo che svolgono: tutti sapranno di aver scelto di ricostruire pietra su pietra quei cinque edifici perché importanti nella memoria secolare dello spazio pubblico, e si sarà fieri di spendere una montagna di soldi per riavere quel bene comune. Ma allo stesso tempo si saprà che la fila di case sull’asse maggiore saranno ricostruite senza vincoli salvo un’altezza massima, un certo allineamento e un certo rapporto tra muri e finestre, ma che al piano terra dovranno rimanere spazi adatti alle nuove esigenze del commercio. O che ai bordi le case potranno anche essere diverse da quelle attuali ma mantenendo comunque l’aspetto di continuità del costruito, come fossero mura che distinguono il borgo dalla campagna. O viceversa… dipende da cosa risulterà da quelle giornate.
E’ una modalità di partecipazione, che devono rispettare anche i tecnici di controllo, perché rispettosa della storia dei luoghi, oggi fatta anche dal terremoto, che comunque lascerà tracce indelebili modificando il paesaggio e il suo senso, ma lasciando una comunità più forte, proprio per aver guidato la propria identità attraverso le traversie della distruzione fisica. Come ci illumina Bauman: “Una vita felice si ottiene superando le difficoltà, fronteggiando i problemi, risolvendoli, accettando la sfida. Accetti una sfida, fai del tuo meglio e ti impegni a superarla. E poi sperimenti la felicità nel momento in cui capisci di aver tenuto testa alle difficoltà e al destino.”
© Riproduzione riservata