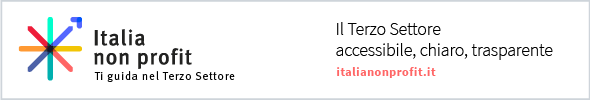Ci sono tre criticità principali
Un rapporto annuale sulle Fondazioni di diritto civile che voglia rispettare il sano principio dell’onestà intellettuale non può prescindere, a parere di chi scrive, dall’esame di alcune delle principali criticità del settore e precisamente di tre di esse: la prima, che potrebbe apparire al contrario un elemento positivo, è il proliferare di iniziative di trasformazione di enti esistenti nella forma del diritto pubblico in fondazioni (generalmente di partecipazione), per meglio essere gestiti. La seconda criticità, che richiede un esame più approfondito, è quella relativa alle (carenti) regole di accountability del settore e alle (assenti) conoscenze scientifico-statistiche del medesimo. La terza infine, che coinvolge strettamente le speranze di sopravvivenza di molte fondazioni, è quella relativa al trattamento fiscale-tributario.
Le tre criticità cui mi riferisco sono strettamente collegate e, come vedremo, praticamente interdipendenti. Non vi è dubbio che la crescita del numero e dell’importanza delle Fondazioni, da quando nel lontano 1996 misi a punto la struttura della Fondazione di Partecipazione, abbia assunto dimensioni inimmaginabili. Se, infatti, la ricerca condotta con riferimento all’anno 1995 dalla Fondazione Agnelli aveva portato a ritenere esistenti circa 1.500 fondazioni sul territorio nazionale, oggi gli osservatori del settore danno per certo che il loro numero abbia superato abbondantemente le 10mila unità.
Viene naturale domandarsi quale sia stata la causa di questa crescita improvvisa nel corso di pochi anni, se si tiene conto che, nel secolo precedente, il settore era rimasto come congelato e ridotto alla presenza di poche fondazioni con ricchi patrimoni iniziali e che, sempre secondo la ricerca sopra menzionata, esse erano ormai in stragrande maggioranza sottopatrimonializzate, al punto di rischiare lo scioglimento per impossibilità di raggiungere gli scopi.
Ebbene, la risposta a questo interrogativo non può prescindere dall’analisi del momento storico-economico che contraddistinse la prima metà degli anni novanta del secolo scorso.
Gli Stati europei, di fronte agli avvenimenti che avevano avuto inizio il 9 novembre del 1989 con la caduta del Muro di Berlino e alla conseguente probabile, vicina riunificazione delle due Germanie, furono costretti ad accelerare la creazione di un’Europa che non fosse solo nelle parole e nei desideri, oltre che in alcuni trattati economici. Nasceva così, il 7 febbraio 1992 a Maastricht (cittadina olandese che altrimenti nessun europeo avrebbe forse mai conosciuto), l’Unione Europea e, con il trattato, si fissava al 1999 il traguardo per raggiungere l’unità monetaria, stabilendo altresì i parametri di convergenza cui gli Stati membri avrebbero dovuto attenersi, per non restare esclusi.
Iniziammo così a sentir parlare di Pil e di rapporto deficit/Pil, senza forse comprendere bene che questo acronimo avrebbe influenzato in misura rilevante la nostra vita negli anni a venire. Mantenere le economie degli Stati membri entro i parametri di Maastricht, infatti, comportò negli anni seguenti alcuni necessari, fondamentali cambiamenti nei comportamenti dei governi e dei cittadini europei, soprattutto in quegli Stati che, come il nostro, avevano condotto scellerate politiche di aumento del debito pubblico al fine di mantenere la pace sociale. Maastricht, in sostanza, significava che lo Stato assistenziale e sprecone era morto e che lo Stato moderno avrebbe dovuto essere leggero, regolare e controllare ma non più gestire le attività economiche (chi come me ha i capelli bianchi, ricorda che le aziende di Stato vendevano panettoni, olio, alimentari, gestivano autostrade, energia, insomma coprivano larga parte dell’economia del Paese).
Come è purtroppo tradizione, tra i tagli più consistenti alla spesa pubblica dovemmo constatare esservi proprio quelli alla Cultura, nella totale sordità alle grida disperate di coloro che, illuminati, facevano presente che questo settore in Italia potrebbe essere trainante per l’economia, i posti di lavoro, il turismo compatibile e responsabile e così via.
I tagli dello Stato si riverberarono sugli enti locali, che, ovviamente, per prima cosa ridussero anch’essi i fondi per la Cultura. Non potendo certo chiudere i teatri, i templi della lirica, i musei, alcuni amministratori, sia a livello centrale che periferico, cercarono di individuare soluzioni che consentissero di conciliare la necessità di ridurre la spesa con il mantenimento di un livello di produzione culturale e di tutela dell’immenso patrimonio che le generazioni precedenti ci hanno lasciato da custodire e preservare.
Nel campo del Privato, frattanto, si cercò ugualmente di individuare soluzioni che consentissero di trovare nuove risorse e ridurre gli sprechi di quelle esistenti. I proverbi popolari hanno sempre un fondamento di saggezza empirica, per cui quello che dice: «La necessità aguzza l’ingegno» trovò in quei momenti la sua conferma.
Dal lato del Pubblico, con le leggi Bassanini del 1996-1997, si stabilì il principio per cui tutti gli enti, la cui veste pubblica non fosse indispensabile, dovessero essere trasformati con atto governativo in fondazioni di diritto privato. Dal lato del Privato, nacque il desiderio di collaborazione tra Assolombarda, Confindustria e Governo, che mi portò a mettere a punto un nuovo modello di Fondazione, che definii «di partecipazione», per dotare le intese tra Pubblico e Privato di uno strumento giuridico idoneo.
Iniziò così il periodo delle trasformazioni per decreto legislativo, che vide la nascita delle fondazioni liriche, della nuova Biennale di Venezia, della Triennale di Milano, del Museo della Scienza Leonardo da Vinci e di molte altre realtà sul territorio nazionale.
Su questo esempio, molte Regioni, Province e Comuni in tutta Italia iniziarono a «trasformare» i propri teatri, musei, orchestre in Fondazioni di Partecipazione, con la speranza di migliorarne la gestione e di reperire nuove risorse. Non sempre, però, queste trasformazioni furono condotte nel migliore dei modi.
Le amministrazioni meglio guidate compresero il vero scopo dello strumento e lo utilizzarono nel modo giusto. La Fondazione di Partecipazione, infatti, era nata per consentire in modo stabile la sinergia tra Pubblico e Privato, una collaborazione equilibrata nella quale ognuno dei due partecipanti avrebbe dovuto portare le proprie funzioni e competenze. Al Pubblico, la funzione di controllo interno e garanzia del perseguimento dell’interesse generale; al Privato, la funzione della capacità manageriale, del gestire l’attività culturale come se fosse un’impresa (fu allora coniato il termine «Impresa Culturale»).
Una sinergia corretta e produttiva, dunque, non era compatibile con le logiche lottizzatorie di certa politica: era essenziale che le persone venissero scelte in funzione delle capacità e non della tessera di partito. Questa è dunque la principale criticità di tutte le «trasformazioni»: laddove si costituisce una vera Fondazione di Partecipazione, nella quale i ruoli sono corretti e le persone sono scelte con criteri effettivamente funzionali, il progetto decolla e la gestione è, sotto tutti gli aspetti, migliorativa della gestione attraverso forme di diritto pubblico. Laddove, al contrario, si creda di poter utilizzare la Fondazione di Partecipazione quale mezzo per distribuire posti di lavoro clientelari e aggirare le lentezze burocratiche e i controlli tipici del diritto pubblico, il progetto è destinato a fallire o, quantomeno, a non produrre i risultati economici sperati.
Ho visto tante Fondazioni costituite da Comuni che, dopo diversi anni, hanno ancora come unico partecipante il Comune di provenienza e come amministratori alcuni ex amministratori comunali.
Non aveva senso, in questi casi, la trasformazione in Fondazione di Partecipazione, sono stati soldi sprecati, sarebbe stato meglio continuare come prima. Proviamo ora a immaginare che si sia costituita una vera Fondazione di Partecipazione, con partecipanti pubblici e privati, che disponga di risorse provenienti da entrambe le componenti e dalle proprie attività. Essa opera secondo i migliori principi di efficacia, efficienza ed economicità e riesce a conseguire il pareggio o il quasi-pareggio di bilancio.
Tutto bene? No, perché qui entra in gioco la seconda criticità: le carenti regole di accountability e l’assenza di un database scientificamente costruito, che consenta la conoscenza anche statistica del settore.
Nessuna norma prevede l’obbligo di un controllo dei conti della Fondazione, né tantomeno la necessaria redazione di un bilancio secondo criteri ben regolamentati. Nessuna norma impone criteri trasparenti per la scelta degli amministratori e regole comportamentali per gli stessi. Nel Regno Unito, da secoli, chi vuol accedere ai benefici riconosciuti alla Charity deve rispettare invece tutte le regole che da noi sono assenti. Mi spiego, non voglio sostenere che sia opportuno limitare lo spazio di libertà delle Fondazioni, ma che una sana autoregolamentazione statutaria, magari incentivata da benefici altrimenti non conseguibili, permetterebbe la trasparenza e il controllo sociale sull’operato di questi enti, producendo di conseguenza maggior fiducia e, quindi, un maggior importo di donazioni.
Voglio dire che sarebbe interesse di ogni Fondazione dotarsi di regole di trasparenza e accountability e farlo sapere al pubblico, al fine di attrarre consensi e risorse economiche.
Ho qui toccato il secondo aspetto di questa criticità: la mancanza di conoscenza tecnico-scientifica del settore e di un database affidabile. Anche qui lo sguardo corre al Regno Unito, ove la Charity Commission è in grado di sapere in ogni momento quante associazioni e fondazioni (Charities) a scopo benefico esistono, quanto denaro raccolgono, come lo spendono, chi sono gli amministratori, insomma tutto quanto occorra conoscere per avere una visione completa del settore. Questo grazie al fatto che, se non si è iscritti alla Charity Commission, non è possibile accedere ai benefici fiscali.
In Italia la situazione è diametralmente opposta: non esiste un archivio o un database pubblico, la scelta del Legislatore nel 2000, quando fu riscritta la norma sul riconoscimento della personalità giuridica, fu, anziché quella di utilizzare il comodo e preciso strumento informatico del Registro Imprese, aprendo una sezione appositamente dedicata agli enti no profit, quella di affidare il riconoscimento alle Regioni e alle Prefetture, la maggior parte delle quali gestisce i fascicoli nella ottocentesca forma cartacea. Ciò significa che, volendo conoscere anche solo il numero delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, bisognerebbe chiedere la cortesia di poter accedere ai fascicoli e ai registri cartacei e farli scorrere uno a uno, ripetendo l’operazione in tutte le Prefetture e le Regioni d’Italia. Dopo qualche anno, avremmo dei dati imprecisi e non più aggiornati.
Nel privato, sino a poco tempo fa era operativo l’Osservatorio della Fondazione Giovanni Agnelli, che, con gli scarsi mezzi a disposizione, faceva del suo meglio per gettare un poco di luce sul settore. Ora l’Osservatorio è stato chiuso e non abbiamo più notizie, come non ci risulta esista più l’Osservatorio Istat.
Terza criticità è data dal trattamento tributario di tutto il settore non profit, regolato con una legge non vecchia (la legge Zamagni, d.lgs. 460 del 7 dicembre 1997), ma che, sin dalla sua emanazione, ha fatto discutere e ha mostrato non pochi, gravi, difetti. L’impianto della legge mostra una diffidenza verso tutto il mondo del no profit italiano che non può essere giustificata dai casi (che pure ci sono) di truffe e finte associazioni, che altro non sono che enti lucrativi mascherati.
Mi spiego: la legge detta tutta una serie di prescrizioni cogenti e formalismi cui ci si deve attenere pena la perdita dei benefici fiscali, non considerando che, nelle legislazioni più aperte, due fondamentalmente sono gli elementi presi in considerazione. Il primo è il perseguimento di fini a beneficio della collettività e non di ristretti gruppi di individui, da cui consegue l’assoluto divieto di distribuzione di utili o rendite. Il secondo è la gratuità della cariche, alla quale sono collegati obblighi di trasparenza contabile. Ebbene, la norma italiana trascura quasi completamente le finalità degli enti in oggetto, preferendo continuare nella tradizionale forma di tassazione in base alle attività e non ai soggetti. Certo, detta rigorose regole per evitare la distribuzione degli utili, ma poi obbliga alla redazione solamente di un «rendiconto economico finanziario» e non di un vero bilancio, chiaramente interpretabile.
Vogliamo quindi essere propositivi e proviamo a pensare, senza preconcetti, una moderna regolamentazione che possa risolvere contemporaneamente le tre principali criticità cui abbiamo accennato. Proviamo a chiarirci quali siano gli obiettivi che intendiamo raggiungere e, di conseguenza, quali possano essere gli strumenti giusti. Esiste il problema dei controlli e dell’accountability; esiste il problema delle risorse insufficienti da parte privata e del graduale venir meno delle risorse pubbliche. Esiste il problema della necessità di incentivare la donazioni e l’autofinanziamento.
Proviamo allora, riprendendo il ragionamento di cui sopra, a immaginare che le Fondazioni che si dotino di regole statutarie interne che garantiscano l’effettivo controllo e la trasparenza dei conti, adottando volontariamente la presenza di organi di revisione legale dei conti con poteri e doveri uguali a quelli delle società per azioni, che si obblighino alla redazione di un bilancio con nota integrativa secondo le regole delle società per azioni, che sottopongano tali statuti e bilanci al giudizio di Commissioni create all’interno dei Ministeri competenti (per il nostro campo, ovviamente, il MiBac), composte da funzionari ed esperti del settore, che gratuitamente prestino la propria opera, ricevano di conseguenza una certificazione che consenta a privati e imprese di effettuare in tranquillità erogazioni per finanziare i progetti delle Fondazioni stesse, deducendo dal proprio reddito d’impresa o di persona fisica le somme erogate.
La soluzione prospettata ha il pregio di essere semplice, di assomigliare molto a quella in essere in altri Paesi di grande tradizione come il Regno Unito, di poter venire introdotta con una piccola modifica della legislazione vigente. Se poi a essa aggiungessimo la possibilità di autofinanziarsi con i ricavi delle proprie attività, in agevolazione d’imposizione tributaria, credo potremmo iniziare a vedere un poco di luce alla fine del tunnel.
O preferiamo continuare a lamentarci e andare in piazza a protestare contro i tagli alla Cultura, trascurando il fatto che l’autofinanziamento è più dignitoso e rende le istituzioni culturali assolutamente libere dal potere politico, non dovendo più essere costrette ad andare dal «Principe» con il cappello in mano a chiedere l’elemosina?
Discutiamone, avanziamo altre proposte, tutto purché si costruisca un sistema migliore dell’attuale.
❑ Enrico Bellezza già notaio, è Professore a contratto in Legislazione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica di Milano
© Riproduzione riservata