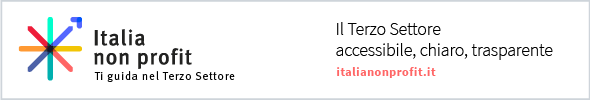Il dovere di dire la verità
Dopo ventisette anni Anna Somers Cocks, presidente del Consiglio di Amministrazione della Umberto Allemandi & Co. Publishing Ltd, lascia, «per iniziare una nuova vita», «The Art Newspaper», il partner in lingua inglese di «Il Giornale dell’Arte», che ha fondato nel 1990 per iniziativa di suo marito, l’editore Umberto Allemandi, e di cui è stata direttrice sino al 2003.
Anna Somers Cocks è per molte ragioni legata all’Italia e non solo perché è nata a Roma ed è moglie di Umberto Allemandi, fondatore e direttore di «Il Giornale dell’Arte», ma anche perché dal 1999 al 2012 è stata presidente di Venice in Peril, la Charity inglese per la salvaguardia di Venezia. Trustee della Gilbert Collection e del Fai Uk, è membro del consiglio di amministrazione del Sotheby’s Institute. Tra numerosi riconoscimenti e onorificenze ricevuti, il premio annuale del National Art Collections Fund (1992), la nomina a Commendatore della Stella per la Solidarietà (2004), il premio ottenuto nella sezione Arte e Media nella 16ma edizione dell’European Woman of Achievement Awards (2006) e l’Advocate Award conferitole nel 2011 dall’International Institute for Conservation. Nello stesso anno è stata nominata dalla Regina d’Inghilterra Officer of the Order of the British Empire (Obe).
Lei avrebbe potuto avere una carriera accademica o nel mondo museale. Perché ha preferito dedicarsi al giornalismo?
Giovanissima, dopo le mie due lauree, dal 1973 al 1986 sono stata curatrice al Victoria and Albert Museum di Londra. Lì ho imparato a conoscere da vicino le opere d’arte e questo mi è piaciuto molto. Ma a un certo punto mi sono detta: io curo mostre e scrivo saggi per le stesse sei-sette persone. Adesso vorrei comunicare.
Nel 1986 mi venne offerta la direzione della rivista «Apollo». Presto scoprii che non aveva un vero e proprio mercato: era una rivista di storia dell’arte per persone colte interessate a molti versanti dell’arte, una tipologia di pubblico oggi sempre più rara. Un giorno lessi per la prima volta «Il Giornale dell’Arte». Ciò che mi piaceva maggiormente è che mi sembrava unisse tutti gli aspetti del mondo dell’arte (arti visive, archeologia, restauro, editoria, mercato ecc.) e che per questa sua caratteristica avesse una vera utilità. Io sono una persona che deve sentirsi utile. Perciò volli conoscere Umberto Allemandi, che mi pregò di lanciare «The Art Newspaper» seguendo la stessa struttura, anche se con notizie in gran parte diverse perché il pubblico anglofono è culturalmente diverso rispetto a quello italiano, come lo è la realtà anglosassone rispetto alla vostra.
Quali erano, e quali sono tuttora, le maggiori differenze?
Non possiamo essere capillari come «Il Giornale dell’Arte», che si rivolge a un pubblico professionalmente più omogeneo e che entra nello specifico di ogni regione, di ogni Soprintendenza... «The Art Newspaper» ha lettori in Australia, in Canada, nelle Americhe, oltre allo stesso Regno Unito. Per questo abbiamo dovuto essere più selettivi nella scelta delle notizie. Una delle peculiarità di «The Art Newspaper» è sempre stato il giornalismo d’inchiesta. Recentemente, ad esempio, abbiamo sviluppato le indagini sull’esposizione di falsi dell’Avanguardia russa al museo di Gand, rivelando il vertice di un enorme scandalo. Il nostro giornalista ha scoperto che tutte le provenienze indicate erano false o contraffatte.
«The Art Newspaper», recentemente, sembra riservare un’attenzione speciale al Medio Oriente.
A me interessa molto il mondo non occidentale perché credo che stiamo vivendo un momento di enorme cambiamento del rapporto dell’Occidente con il resto del mondo. Ma intorno a questo mutamento c’è anche molta diffidenza e paura, specialmente rispetto al Medio Oriente. Eppure quando nel 2004, in una fase in cui l’Iran era considerato il nemico numero uno dell’Occidente, tenni una conferenza nel Museo d’arte contemporanea di Teheran, incontrai persone coltissime che conoscevano la nostra filosofia, giovani che ascoltavano ogni parola. Avevo invitato una femminista ebrea di New York e nessuno le impedì di parlare. Ritengo sia nostro dovere conoscere quelle realtà e comunicarle all’Occidente. Per questo abbiamo realizzato un prodotto editoriale con Abu Dhabi in occasione dell’apertura della sede del Louvre negli Emirati Arabi. Non si tratta solo di una rivista, ma anche della realizzazione di filmati nei quali abbiamo chiesto a cittadini di Abu Dhabi, alcuni molto illustri, di individuare un’opera d’arte del museo e di spiegare che cosa vedessero in quell’opera. La visione non occidentale dell’arte europea è molto affascinante. Ma questa apertura delle menti e degli occhi, che può essere attivata dal contatto con le opere d’arte, dovrebbe avvenire anche in Occidente, dove si dà per scontato che tutto sia conosciuto. Invece, abbiamo già perso la conoscenza della mitologia greca e latina e stiamo perdendo, specialmente nel Nord Europa, la conoscenza della tradizione cristiana. Non possiamo dare per scontato che una rappresentazione dell’Annunciazione sia capita da tutti. Questo non perché le persone oggi siano più stupide, ma semplicemente perché ora sanno cose diverse. Questa sarà una sfida per l’Italia. Una volta tutti conoscevano la cultura europea e al centro di questa cultura c’era l’Italia e si dava per scontato che una persona colta conoscesse la vostra cultura. Nel mio ufficio avevo tredici giornalisti e solo io e un’altra persona conoscevamo l’arte prima dell’Ottocento.
È assurdo...
No, questo è normale in Inghilterra e in America.
Perché?
Perché le cose di cui stiamo parlando non vengono più insegnate. Al contrario, in Russia, dove le cose sono rimaste un po’ più ferme, solo l’arte antica è veramente accettata. Sa che soltanto tre mesi fa la normativa legale russa ha incluso quella contemporanea nella categoria «arte»? Prima era classificata come oggetto di lusso e tassata in quanto tale.
Rispetto a ventisette anni fa, quando nacque «The Art Newspaper», il mondo è radicalmente cambiato, anche quello dell’arte. Inevitabile, a questo punto, parlare di come internet ha cambiato il modo di fare giornalismo. Anzi, per essere più precisi: è vero che internet può mettere fine al giornalismo così come lo abbiamo inteso per tanto tempo?
Se lasciamo che succeda, sì. Se rinunceremo a priori a fare lavorare determinati giornalisti e a dedicare del tempo per produrre un giornalismo d’indagine e necessariamente più lento, tutto si ridurrà a una cosa prodotta molto rapidamente, una specie di diarrea delle notizie, attraverso la quale si ha una vaga idea di quello che succede. Avremo forse risposte ad alcune delle famose regole del giornalismo di Rudyard Kipling (chi?, dove?, come?, quando?), ma alla fine non avremo tempo per rispondere alla domanda più importante: perché? Un’altra difficoltà riguarda l’aspetto economico: è sempre più difficile finanziare il giornalismo di qualità perché internet offre molto gratuitamente e ci costringe ad avere «fast time news» e «slow time news». Bisogna essere consapevoli di questo.
Sono cambiati i lettori come il pubblico delle mostre. O è cambiato il modo di produrre le mostre?
Conta molto il richiamo pubblicitario. La mostra sulla collezione del re Carlo I d’Inghilterra, che venne decapitato anche perché spendeva molto denaro in opere d’arte, sta ottenendo un flusso di pubblico enorme, attratto dal pathos di quella mostra (cfr. «Il Giornale dell’Arte» n. 382, p. 43, Ndr). Anche Basquiat è seguito da tutti, dai giovani, dalle persone che normalmente non vanno ai musei, perché il suo mito parla. Prenda invece un grande del passato come Perugino. Molto probabilmente la mostra sarà poco visitata perché nessuno sa chi sia.
In Italia si pensa spesso che all’estero ci sia più sensibilità del pubblico nei confronti delle mostre. Le faccio però un esempio contraddittorio: nel ’97 il Metropolitan Museum di New York organizzò una splendida retrospettiva su Winslow Homer: si faceva fatica a muoversi tanto era il pubblico. Hercules Seghers, in Olanda, è una gloria nazionale ed è un personaggio affascinante, misterioso, maledetto. Nel 2016 il Rijksmuseum gli ha dedicato una retrospettiva irripetibile. Le sale erano semideserte. Come spiega questi fenomeni?
Il Metropolitan occupa una posizione insolita in una città a sua volta insolita. New York è una città «murata», la penso come una grande Siena di una volta, è una città che guarda a se stessa ed è molto orgogliosa di se stessa. Il Metropolitan è come uno dei suoi fari e ha coltivato nel pubblico di New York una grande fiducia in quello che fa. E al Met sanno bene che tutti i turisti a New York e tutti i newyorkesi lo conoscono e lo visitano. Ho visto al Met una mostra su Tilman Riemenschneider, uno scultore tardogotico tedesco, sconosciuto ai più. La mostra però era affollatissima: se è al Metropolitan, la gente ha fiducia e pensa che la mostra valga la pena di essere visitata, qualsiasi cosa sia. Provi a fare una mostra sugli arazzi a Firenze: non ci andrebbe nessuno.
Quindi la comunicazione è tutto?
Bisogna essere bravi nella comunicazione, il che non vuol dire fare tanta pubblicità nella metropolitana, ma essere solo bravi a spiegare le cose. Italia, Francia e Germania sono ancora un po’ elitarie: gli storici dell’arte scrivono per altri storici dell’arte, anziché per il pubblico, che non è stupido nonostante non conosca le cose che sanno gli specialisti. Dunque bisogna imparare a spiegare. Alla Galleria Sabauda di Torino ho sentito un bambino italiano chiedere al papà che cosa significasse l’acronimo «Inri» su un crocifisso e il papà non lo sapeva. Bisogna spiegare le cose, anche quelle che ci sembrano scontate.
Quale ruolo possono concretamente avere i nuovi media nella comunicazione e nella formazione?
Ho una grande ammirazione per la fondazione Google Earth. Usa immagini ad altissima risoluzione e si può avere veramente l’esperienza di un’opera d’arte come fosse sotto i nostri occhi, come normalmente solo un curatore di museo potrebbe fare. Ti dà questo «plus contact» con l’opera d’arte e i musei possono utilizzarlo come vogliono. La gente è abituata a vedere una cosa su uno schermo e non ne ha paura. Ha invece paura di entrare in un luogo «speciale» dove c’è una «distanza» tra opera e osservatore. Google Earth non appiattisce l’opera d’arte, ma la rende familiare, elimina la distanza.
Non si perde la percezione fisica delle dimensioni dell’opera?
Naturalmente quello si perde, ma succede che le persone iniziano a familiarizzare con le opere e poi un giorno capiterà loro di andare a vedere l’opera reale.
Quali sono tra i molti, i principali problemi della cultura in Italia?
Non vorrei ripetermi, ma il primo è che la cultura è ancora considerata una cosa di élite e dunque non si considera a sufficienza la comunicazione. Il secondo è un cinismo di base, per cui magari i politici e i grandi imprenditori a parole esaltano il ruolo dell’arte e magari comprano anche libri importanti, salvo poi non leggerli. Infatti quando si arriva al dunque prevalgono gli aspetti più materiali.
Lei è impegnata in prima linea nella salvaguardia di Venezia, che da sola è uno dei grandi problemi nazionali...
È l’esempio classico del cinismo di cui ho appena parlato. Tutti dicono che Venezia è un patrimonio dell’umanità e intanto la si sta rovinando perché non c’è nessuno che prenda veramente posizione e dica: «Questo è un luogo speciale e dunque devono essere adottate misure speciali». Nessuno degli ultimi sindaci l’ha capito, nemmeno Cacciari che è filosofo. C’è stata una grande «trahison des clercs» da parte dei sindaci: dopo Cacciari, Orsoni e adesso Brugnaro.
E lei ha delle idee?
Nel 2013 ho scritto sull’argomento un grande articolo per «The New York Review of Books», che ha un enorme richiamo nei Paesi anglosassoni. Qui in Italia mi danno un bel premio e si va avanti come prima. Attualmente la gestione e gli obiettivi del turismo sono una cosa, il mondo della cultura un’altra. Hanno cominciato a dialogare, ma dovrebbero collaborare strettamente per una ragione economica molto importante: il mondo del turismo è considerato un mondo di soldi che entrano e il mondo della cultura è considerato un mondo di soldi che escono. Se li si unisse, si capirebbe che non sono in opposizione, ma assolutamente complementari.
Anche il livello della critica e degli studi di arte contemporanea si è molto abbassato.
Una volta l’arte contemporanea era considerata un fatto culturale, sociale e politico importante e dunque uno storico, un critico dovevano capirla se volevano partecipare nel mondo moderno. Adesso c’è tantissima arte che Chris Dercon, l’ex direttore della Tate Modern, chiama Zombie Art, cioè arte che all’apparenza è viva, ma in realtà è morta, perché si sta producendo moltissimo, ci sono troppi artisti e il mercato appiattisce tutto.
Il mercato, appunto: anch’esso ha subito mutamenti radicali...
È arcinoto che è diventato un ramo del mondo della finanza. Questi prezzi sono spiegabili solo in questi termini. Esiste un parallelismo tra l’acquisto irragionevole di azioni di certe imprese e l’acquisto irragionevole di certe opere d’arte. Il problema è che i giornalisti della finanza e i giornalisti dell’arte non sono la stessa cosa ed è veramente tragico vedere come alcuni artisti, quando comincia una speculazione, crescono a dismisura, cosa che poi appiattisce il mercato di altri artisti più vari, più interessanti, più difficili. La speculazione è una cosa che rende cretini.
Molte fiere, a parte le grandissime come Art Basel o Tefaf, avranno concorrenti sempre più temibili nei canali di vendita online. Questa però non è una buona notizia neanche per la raccolta pubblicitaria dei media specializzati...
Sotheby’s e Christie’s hanno cominciato a capire circa cinque anni fa che se avessero realizzato bei filmati dedicati alle opere in vendita, se avessero fatto del marketing diretto ai loro clienti, non avrebbero assolutamente avuto bisogno di noi. Eppure continuano a fare pubblicità con noi. È una specie di atto di patrocinio, la vedono in questo senso. Dunque bisogna vendere la pubblicità su questa base, bisogna dire non solo: «Guardate, avrete questa visibilità», ma anche «noi stiamo preparando il terreno per voi». E lo facciamo nel momento in cui facciamo capire al pubblico il mondo dell’arte e come ci si può entrare come acquirenti.
Non trova paradossale che l’arte contemporanea, prodotto di nicchia per antonomasia, sia diventata così popolare tra il pubblico?
Anch’io lo trovo un fenomeno incomprensibile. Forse si deve al fatto che l’arte contemporanea è proposta in luoghi che sembrano cool: le fiere hanno fatto molto di più in questo senso che non le mostre. C’è un finanziere newyorkese che ha scritto che arte e soldi insieme sono sexy. Io non credo che l’arte antica sia sexy. Pubblicità, «evento» e soldi intorno all’arte richiamano gente anche se non ci capisce molto. Poi c’è l’arte che si capisce facilmente, la fotografia ad esempio. Sono stata a una mostra di Gursky e c’era moltissimo pubblico. Gursky si capisce in due secondi. Bravissimo, ha fatto delle belle immagini, ha cambiato un po’ la nostra visione, che cosa vogliamo di più? Però non c’è moltissimo da dire su quello che fa.
E se il mondo dell’arte fosse complice di un fenomeno diffuso come l’ignoranza della memoria storica?
È terrificante. L’America è un Paese che ha perso la sua memoria. Gli americani, ad esempio, non sanno che cosa sia il Secondo emendamento della loro Costituzione, che è quello che permette il porto d’armi. Nell’epoca in cui avevano sconfitto gli inglesi e non c’era un esercito fisso, in America ci si affidava a milizie, come in Svizzera. Ognuno doveva avere la propria dotazione di armi per motivi molto seri, perché non si sapeva se e quando sarebbero tornati gli inglesi, non per le futili ragioni di oggi. Questo la gente non lo sa. Hanno dimenticato perfino che cosa sia stata la guerra del Vietnam: è emerso da un’inchiesta condotta in California quando si stava avvicinando la seconda guerra in Iraq, che si sapeva sarebbe stata un disastro, un nuovo Vietnam appunto. Stiamo vivendo momenti molto, molto pericolosi e la perdita del senso del contesto è la perdita del valore della verità. Ognuno di noi come giornalista ha il dovere di ricordare che cosa sia la verità, di dimostrare la verità.
In Italia le elezioni sono state vinte dai populisti, non certo noti come custodi della memoria. Tra l’altro non ricordo un politico che in campagna elettorale abbia parlato di salvaguardia del paesaggio.
Se mi chiedessero di scegliere tra un bel dipinto e un paesaggio io non avrei dubbi, sceglierei il paesaggio, perché è una cosa costruita attraverso i secoli, è un organismo fragile, vivente. Ritorno a quello che ho detto già prima: occorre pensare ad ogni atto nel contesto in cui viviamo. I verdi, gli ecologisti sono stati messi all’angolo. Eppure la salvaguardia dell’ambiente sarebbe l’unico modo per guarire dalla terribile infelicità che vediamo dappertutto: siamo più benestanti eppure più infelici che mai.
Gli artisti possono avere un ruolo per migliorare la nostra vita?
Già fare un’opera molto bella è un piccolo contributo, ma questo non è considerato. Viviamo in un momento in cui operano tante chiese. Aestheticism è una di quelle, se parliamo di artista come attore sociale. Penso, ad esempio, a Theaster Gates: praticare l’arte per le persone che normalmente non hanno un aspetto creativo nella loro vita può essere di grandissimo valore. Mi piacciono i progetti come «The Big Draw» in Inghilterra, un grande movimento che si riunisce una volta l’anno e che incoraggia le persone dappertutto a disegnare. In questo caso l’arte ha un valore obiettivo, e anche terapeutico. Alcuni grandi matematici inglesi sostengono il progetto «The Big Draw» perché sostengono che il grande pensiero matematico va individuato più come un modo di disegnare con la mente che non fare un’addizione.
E gli artisti?
Il significato autentico dell’arte bisogna andarlo a cercare come un frammento d’oro in una miniera. Io lo trovo nei Paesi in cui la vita è difficile. Per esempio trovo che gli artisti sauditi sono serissimi, hanno capito subito l’arte concettuale e con questa esprimono tutta la frustrazione di vivere in una società dominata da un clero fanatico, con delle brutalità e delle chiusure che loro esprimono metaforicamente.
Torniamo al nostro mestiere di giornalisti. Per il cartaceo è davvero finita?
Secondo me, no. Ritorno a quello che ho detto prima: ci sono fast news e slow news. Io credo che si debbano dedicare i siti web a fast news perché a nessuno piace leggere un articolo di 10 cartelle online. Lo fai solo se sei costretto a farlo, ma non è un piacere. È molto più bello leggere un testo lungo su carta. Era stata annunciata la morte dei libri stampati, invece non accade. I libri stampati continuano a esistere, è un modo diverso, direi fisiologico di interazione con la parola. Bisogna allora pensare che cosa saranno i giornali in futuro. I giornalisti dovranno essere molto più intelligenti nei loro commenti e sapere come fare il riassunto rapido di quello che è successo per poter dedicare spazio al commento. Credo inoltre che gli editori dei giornali possano offrire l’accesso agli archivi a pagamento; si possono offrire tante cose, ma bisogna riflettere molto bene su quello che si sta facendo. Tutti stanno mettendo un paywall, ma dietro il paywall ci deve essere roba che è «really indeed to know», nessuno è disposto a pagare per la diarrea delle notizie.
A questo punto immagino che anche il suo futuro sarà dedicato a un concetto più attuale e necessario di comunicazione o sbaglio?
Non voglio occuparmi d’arte. Mi piacerebbe piuttosto dedicarmi alla comunicazione dell’arte. Mi interessa molto scoprire quello di cui le persone hanno bisogno e poi saperlo spiegare. Se farò giornalismo, lo farò per cercare di sensibilizzare le persone su alcuni pericoli incombenti.
Ad esempio?
Per esempio il fatto che, con l’innalzamento dei mari, tutto il Nord-est d’Italia, compreso il ravennate e non solo Venezia, è a fortissimo rischio e nessuno ne parla. Non se ne parla perché gli scienziati non sanno come comunicare e i giornalisti non hanno tempo di andare a parlare con gli scienziati e scoprire quello che bisogna sapere per poi convincere le persone che è veramente così.
Non mi ha ancora detto perché ha deciso di lasciare «The Art Newspaper».
Perché sto per compiere 68 anni e a «The Art Newspaper» ne ho dati ventisette. Ho imparato a fare il direttore di giornale, ho fatto la giornalista, ho viaggiato per il giornalismo, ho tenuto conferenze, ho fondato le edizioni russa e cinese del nostro giornale... Adesso basta, è veramente ora di cominciare l’ultimo capitolo. Gli indù dividono la vita tra la parte da guerriero e la parte da sacerdote.