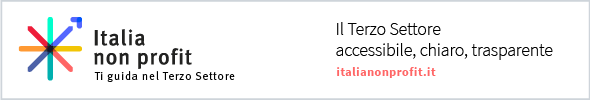I restauri e quella malintesa dicotomia tra «vecchio» e «nuovo»
Negli ultimi anni le aggressioni al patrimonio monumentale da parte di un certo tipo di cultura architettonica divulgata da patinate riviste si fanno sempre più frequenti. Sostenendo le presunte ragioni dell’architettura contemporanea e della sua libertà di espressione, s’intende motivare interventi che attaccano violentemente l’integrità o tendono ad annullare la stessa identità-autenticità dei monumenti. Dal Teatro di Sagunto alla Scala di Milano, all’Opera di Lione, dalla Punta della Dogana al Fontego dei Tedeschi, alle Gallerie dell’Accademia a Venezia, l’elenco è assai lungo e gli attacchi sempre più frequenti, al punto da richiamare l’attenzione degli studiosi in ambito internazionale che si sono riuniti in svariate occasioni per mettere a fuoco e stigmatizzare questa pericolosa tendenza. Fra tali incontri è da segnalare il convegno del 2010 tenutosi a Cracovia, dove è stato prodotto e diffuso un aggiornamento di Carta Cracovia 2000 che denuncia tali ripetute aggressioni e il sottofondo culturale dal quale esse traggono linfa e motivazioni. In Carta Cracovia dieci anni dopo si segnala infatti «la preoccupante tendenza in atto per la quale il patrimonio costruito viene aggredito con interventi che vengono impropriamente definiti restauri, configurandosi invece come “progettazione architettonica” secondo quanto precisato e stigmatizzato dalla Carta di Venezia che costituisce il fondamento stesso di quella di Cracovia. Una forzata interpretazione di quanto in essa prescritto relativamente al “segno della nostra epoca” conduce spesso i progettisti a sovrapporre nei monumenti espressioni linguistiche totalmente difformi da quelle degli edifici che si dovrebbero conservare. E questo in palese contrasto con quanto prescritto agli articoli 12 e 13 del documento».
In questo contesto si situa senz’alcun dubbio il progetto per la «ristrutturazione» dell’ex Ospedale Sant’Agostino a Modena. Ma qui, più che altrove, è da soffermare l’attenzione proprio su quanto viene affermato dai progettisti a sostegno del loro operato. Questi, infatti, rispondendo sulla «Gazzetta di Modena» del 7 febbraio a un intervento di Elio Garzillo che giudicava negativamente il progetto, sostengono che le critiche muovono da «un’idea schematica ed apodittica dei restauri che da molto tempo non risponde più agli orientamenti che in questo campo prevalgono in Italia e in Europa».
È in questa affermazione, che pone le obiezioni e le critiche in un sostrato culturale che si vorrebbe far intendere come sorpassato, consiste, a mio avviso, il pericolo maggiore non solo per i monumenti ma per tutto il patrimonio costruito; forse ancora maggiore della stessa natura e configurazione del progetto del Sant’Agostino. Abbiamo visto infatti, e vedremo in seguito, che è invece la visione culturale a cui fanno riferimento i progettisti a proporsi come decisamente estranea al mondo culturale della conservazione e del restauro.
Il primo punto argomentato a difesa del progetto è già chiaramente significativo, là dove si afferma che si vuole «rendere chiaro […] il rapporto tra conservazione e restauro degli edifici antichi e l’apporto architettonico innovativo necessario al loro futuro utilizzo». Viene subito qui enunciato, e ritenuto «punto cruciale», un argomento che è alla base di tutti gli equivoci che, come in questo caso, vorrebbero giustificare interventi impropri sui monumenti. «Il progetto per il Sant’Agostino», si afferma, «ha per sua natura e statuto due componenti». Queste due componenti vengono definite «progetto di restauro e progetto delle nuove parti architettoniche, strutturali, impiantistiche». L’architetto Garzillo viene accusato dai progettisti di occuparsi soltanto della «componente del restauro».
Posta, e imposta, questa dicotomia tra restauro e architettura del «nuovo», viene di seguito data motivazione, nell’articolo, ai punti più critici dell’intervento, quelli che aggrediscono il monumento nella sua autenticità: i padiglioni che occupano i cortili, la copertura del cortile triangolare, le cosiddette «lame», enormi torri di 23 metri che devastano la spazialità autentica del complesso, i nuovi mezzanini e quanto in riferimento alle librerie storiche. Ma le motivazioni che vengono addotte a sostegno di questi interventi non si riferiscono più all’ambito del restauro ma e ricadono invece esclusivamente nella logica di ciò che troppi, e in modo troppo stucchevole, definiscono oggi «il nuovo»; tali motivazioni riguardano infatti parametri e criteri meramente funzionali e tecnici che non si confrontano più con il costruito esistente, con la sua logica, con il concatenamento dei sui spazi e con la composizione-disposizione dei suoi volumi e delle sue superfici, ma soltanto con le regole proprie della tecnica, oltre che con quelle del mercato delle immagini.
Esse infatti, nel progetto come nelle argomentazioni dei progettisti, non fanno riferimento alla disciplina del restauro, ma a quel «progetto delle nuove parti», dalla logica delle quali discenderà «l’adattamento al nuovo uso». Insomma, come affermano gli architetti, i progetti sono due: uno definito «di restauro» e uno «di nuova architettura»; e questo a prescindere totalmente dalle raccomandazioni dell’articolo 9 della Carta di Venezia. È chiaro in questo senso, allora, che ai restauratori, in procedimenti di questo tipo, viene affidato soltanto il compito di «conservare» quei tratti dell’edificio che non danno noia alle necessità del «nuovo»; laddove a quest’ultimo viene concesso invece d’imporre la sua logica là dove gli necessita, a prescindere dalla logica dell’edificio esistente. Così, nel nostro caso, se si deve traslocare la libreria, si possono inventare le «lame» in dispregio alla spazialità dell’esistente; se c’è bisogno di nuovo spazio, ecco i padiglioni, la copertura del cortile, i nuovi mezzanini, e così via! Le motivazioni ci sono sempre: sono rappresentate unicamente dalle richieste funzionali della committenza, anche se il monumento non le accetta. Delle due logiche, quella del «vecchio» e quella del «nuovo», quando sono in contrasto, è la prima a soccombere in nome della presunta irrinunciabilità alle esigenze funzionali, con la pretesa motivazione addotta da molti, che consisterebbe nel fatto che «si è sempre fatto così»; in fondo anche il Palladio a Vicenza ha totalmente trasformato la Basilica: perché non dovremmo comportarci anche noi così oggi?
Ma, in realtà, questa affermata e sostenuta dicotomia tra il progetto di restauro e il progetto del «nuovo» non è stata codificata da nessuna parte; anzi, la legislazione delle opere pubbliche che riguarda i beni culturali e lo stesso Codice del 2004 affermano che vi deve essere un unico progetto che riguarda i cosiddetti monumenti e cioè l’intero patrimonio costruito; e tale progetto viene definito di «restauro». È infatti in questo progetto unitario che confluiscono le varie branche disciplinari che ne sono imprescindibili parti, come quella strutturale e quella impiantistica, che devono anch’esse tendere a un’unica direzione che è la conservazione e la tutela della vita dell’edificio nella sua autenticità e il suo utilizzo da parte della comunità. Utilizzo che potrà realizzarsi, in modo conforme alla sua salvaguardia, solo dall’esplicazione delle potenzialità d’uso già presenti in esso, nella logica di articolazione e sequenza degli spazi, secondo ben precisi parametri distributivi e compositivi. Un’unica attività progettuale, dunque, può avere a cura la conservazione dei monumenti; e questa è soltanto il restauro che, nella sua centralità disciplinare e operativa, media le varie componenti delle discipline che in esso confluiscono; e non può essere certo il risultato di un’impossibile dialettica tra il restauro stesso e le varie altre discipline. Il restauro dell’architettura, in quanto tale, come sintesi di diversi saperi finalizzati alla conservazione dell’edificio, deve contenere e prendere in considerazione, al suo interno, anche quelle parti di nuova architettura indispensabili all’uso del bene, ma che non possono configurarsi come esito di altre discipline estranee o contrapposte, sia pur dialetticamente, al restauro stesso. Solo attraverso la centralità della disciplina del restauro, ci si può rapportare a quella logica del costruito che ancora esiste, è attuale e nella quale possiamo riconoscerci e che, infine, non può essere contraddetta, pena la perdita del monumento stesso. Quella stessa logica che ci può sostenere nell’affermare che quelle determinate funzioni sono incompatibili con l’integrità sostanziale del monumento, e con la sua autenticità, con il suo essere se stesso senza diventare un’altra cosa, che ci può anche consentire di dire «no» alla committenza, in nome di quel giuramento di Vitruvio che recentemente Salvatore Settis individuava come indispensabile fondamento etico dell’agire dell’architetto.
da Il Giornale dell'Architettura, edizione online, 10 marzo 2014